PREMESSA di Tiziana Pedrizzi
 Fra aprile e maggio si tiene PISA 2018.
Fra aprile e maggio si tiene PISA 2018.
Da quest’anno è stato possibile ai Paesi partecipanti inserire un nuovo elemento: la valutazione delle competenze globali (Global Competency, GC).
Documenti preparatori: Global Competency for an Inclusive World 2016 e Preparing our youth for an inclusive and sustainable world -the OECD PISA global competence framework 2017 a cura di Andreas Schleicher e Gabriela Ramos. Sulla base di questi documenti, sono state prodotte e testate sul campo (field trial) delle prove di cui alcune sono presenti nei due documenti.
Il Quadro di riferimento delle Competenze Globali che ne risulta è particolarmente ampio ed articolato, caratterizzato dal riferimento costante ai documenti di politica scolastica della Comunità Europea, ma anche ad esperienze e ricerche precedentemente condotte sul campo, fra le quali viene attribuita particolare visibilità a quella di Project Zero della Università di Harvard. Sicuramente un importante punto di riferimento sono anche le indagini IEA sulle competenze civiche: International Civic and Citizenship Education Study ICCS 2009 e International Civic and Citizenship Education Study ICCS 2016. Pertanto il contributo peculiare di PISA 2018 dovrebbe essere non solo e non tanto quello di indicare le competenze e gli strumenti per raggiungerle, quanto i modi per valutarle.
La finalità è offrire una prima sistematica sintesi “dei successi dei sistemi educativi nell’equipaggiare i giovani a orientare lo sviluppo globale ed a collaborare produttivamente nella vita di ogni giorno attraverso le differenze culturali”. Conoscenze, abilità, attitudini e valori coerenti con questo campo costituiscono le quattro aree sistematicamente indagate dalle prove. Le quali, oltre ad identificare i contenuti, definiscono anche come metodologie coerenti “attività di role play che aiutino ad assumere prospettive differenti, discussioni sul pregiudizio e le discriminazione o attività di progetto che incoraggino a riflettere sulle radici e le cause dei problemi globali”.
L’obiettivo sembra essere quello di creare una visione del mondo internazionale caratterizzata dal rispetto e dalla comprensione reciproca fra le diverse culture. Finalità non solo quella della convivenza pacifica, quanto quella di creare la possibilità di collaborare in modo efficace, sul terreno del lavoro e della produzione di ricchezza. Cruciale da questo punto di vista l’idea che, sebbene ci siano gruppi (nazionali, etnici, religiosi e culturali) diversi, tuttavia ogni individuo è l’intersezione di più appartenenze differenziate ed in quanto tale si presenta come un unicum in cui i legami di appartenenza sono molto diversi e quindi nessuno decisivo. Pertanto i soggetti, atomizzati e mancanti di appartenenza culturale stabile ed unica possono convivere e comunicare, anche per la produzione.
Lo sviluppo della scienza e della tecnica ha migliorato enormemente le condizioni dell’umanità attraverso la produzione di una grande quantità di beni e servizi, dopo i tentativi falliti del secolo precedente di farlo attraverso il cambiamento della organizzazione delle società umane (comunismo, fascismo-nazismo). L’ideologia produttivistica e prestazionistica si presenta come la continuazione della ideologia del mondo occidentale, senza l’idea della superiorità bianca e la predominanza dei suoi valori. Tutti i valori sono positivi, purché non anti-produttivi in quanto impediscono la convivenza e la collaborazione. Il limite del relativismo assoluto verrebbe evitato dal forte riferimento ai Diritti dell’Uomo che in caso di contrasto dovrebbero prevalere.
I risultati della indagine ed il dibattito che probabilmente li accompagnerà ci diranno quanto questa prospettiva sia realistica. Certamente l’impressione è quella della aspirazione ad imporre una visione “politicamente corretta” ai sistemi educativi ed attraverso questi alle società. Una prospettiva in controtendenza rispetto al riemergere dei localismi, dei tribalismi e del potere identitario delle religioni che per essere competitiva, al di là del potere condizionante del capitale e della finanza internazionale, forse necessita di una maggiore consapevolezza della dimensione storico- culturale della educazione nelle società umane.
C’è da registrare comunque- parallelamente allo sviluppo di questo pensiero figlio dell’89 che viene talvolta definito come neoliberista/ funzionalista – una crescita di interesse del mondo della ricerca per elementi che questa impostazione tende ad accantonare, relativi proprio alle culture ed all’appartenenza, prima di tutto quella religiosa. In questo senso si segnalano anche produzioni provenienti dal mondo laico che prende atto della irriducibilità della dimensione religiosa, intesa come dimensione di appartenenza culturale, fra cui possono essere segnalati il testo collettaneo Religion and Education degli Oxford Studies in Comparative education e l’ultimo numero n 3 del 2017 della rivista italiana Scuola Democratica.
Alcune di queste ricerche sembrano sottolineare l’utilità delle religioni come presidio di valori, anche attraverso il senso di appartenenza e di disciplina che rende possibili gli apprendimenti e pertanto il riconoscimento ed anche l’integrazione. Per raggiungere tutti davvero nella formazione, bisognerebbe garantire anche la formazione morale, che garantisce comportamenti preliminari adeguati alla possibilità di imparare e che a livello delle masse sarebbe data solo dalle religioni. Solo per i paesi del Sud del Mondo o anche per tutti?
Abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione del mondo della scuola un documento interessante, forse importante soprattutto nel futuro; che può comunque essere prezioso anche per le attuali attività di classe dei singoli insegnanti e delle singole scuole che vogliano impegnarsi in questa direzione.
Ci scusiamo per eventuali imprecisioni nella traduzione dovuti all’artigianalità del testo.
PREPARARE I GIOVANI PER UN MONDO INCLUSIVO E SOSTENIBILE
Il Framework della Competenza Globale in OCSE PISA
(traduzione a cura di Tiziana Pedrizzi)

INTRODUZIONE:
L’importanza di una valutazione internazionale della competenza globale
Gli studenti del XXI secolo vivono in un mondo interconnesso, differenziato e che cambia rapidamente. Le forze emergenti economiche, digitali, culturali, demografiche ed ambientale stanno modellando le vite dei giovani del pianeta ed aumentando i loro incontri interculturali ogni giorno. Questo ambiente complesso presenta una opportunità ed una sfida. I giovani oggi devono non solo imparare a partecipare in un mondo più interconnesso, ma anche apprezzare e trarre beneficio dalle differenze culturali. Sviluppare un aspetto globale ed interculturale è un processo lungo una vita, che l’educazione può modellare.
Cosa è la Competenza Globale?
La Global Competency (d’ora in poi GC) è una capacità multidimensionale. Gli individui dotati di GC sanno esaminare i problemi locali, globali ed interculturali, comprendere ed apprezzare differenti prospettive e visioni del mondo, interagire rispettosamente e con successo con gli altri e condurre azioni responsabili nei confronti della sostenibilità e del benessere collettivo.
Le scuole possono promuovere la Competenza globale?
 Le scuole giocano un ruolo cruciale nell’ aiutare i giovani a sviluppare la GC. Possono offrire l’ opportunità ai giovani di esaminare criticamente gli sviluppi globali significativi sia per il mondo che per le loro vite. Possono insegnare agli studenti come usare criticamente, responsabilmente ed efficacemente le piattaforme dei social media. Possono incoraggiare la sensibilità ed il rispetto interculturale permettendo agli studenti di impegnarsi in esperienze che rinforzino l’apprezzamento di popoli, linguaggi e culture diversi. Le scuole hanno anche una posizione unica per rinforzare la capacità dei giovani di comprendere il loro posto nella comunità e nel mondo e di migliorare la loro abilità di giudicare e agire.
Le scuole giocano un ruolo cruciale nell’ aiutare i giovani a sviluppare la GC. Possono offrire l’ opportunità ai giovani di esaminare criticamente gli sviluppi globali significativi sia per il mondo che per le loro vite. Possono insegnare agli studenti come usare criticamente, responsabilmente ed efficacemente le piattaforme dei social media. Possono incoraggiare la sensibilità ed il rispetto interculturale permettendo agli studenti di impegnarsi in esperienze che rinforzino l’apprezzamento di popoli, linguaggi e culture diversi. Le scuole hanno anche una posizione unica per rinforzare la capacità dei giovani di comprendere il loro posto nella comunità e nel mondo e di migliorare la loro abilità di giudicare e agire.
Perché abbiamo bisogno della Competenza globale?
- Per vivere armoniosamente in comunità multiculturali
 L’educazione alla GC può promuovere la consapevolezza culturale ed interazioni rispettose in società sempre più diverse. Dalla fine della Guerra Fredda i conflitti etnico/culturali sono diventati la maggiore fonte di violenza e non mostrano segno di cessare. I molti episodi di violenza indiscriminata nel nome di una affiliazione religiosa o etnica sfidano la credenza che genti di diverse culture siano capaci di vivere in pace l’una accanto all’altra, di accettare le reciproche differenze, di trovare soluzioni comuni e di risolvere i contrasti.
L’educazione alla GC può promuovere la consapevolezza culturale ed interazioni rispettose in società sempre più diverse. Dalla fine della Guerra Fredda i conflitti etnico/culturali sono diventati la maggiore fonte di violenza e non mostrano segno di cessare. I molti episodi di violenza indiscriminata nel nome di una affiliazione religiosa o etnica sfidano la credenza che genti di diverse culture siano capaci di vivere in pace l’una accanto all’altra, di accettare le reciproche differenze, di trovare soluzioni comuni e di risolvere i contrasti.
Con l’alto afflusso di immigranti, in numerosi Paesi le comunità devono ridefinire la loro identità e la cultura locale. Le società contemporanee ricercano forme complete di appartenenza e cittadinanza in cui gli individui interagiscano con regioni, persone ed idee distanti e contemporaneaente approfondiscono la comprensione del loro ambiente locale e della diversità entro le loro comunità. Apprezzando le differenze nelle comunità alle quali appartengono – nazione, regione, città, vicinato, scuola – i giovani possono imparare a vivere assieme come cittadini globali. Se l’educazione non può accollarsi da sola la responsabilità di porre fine al razzismo ed alla discriminazione, può però insegnare ai giovani l’importanza di sfidare i pregiudizi culturali e gli stereotipi.
- Per prosperare in un mercato del lavoro in cambiamento
 Educare alle GC può aiutare la occupabilità. La comunicazione efficace e comportamenti appropriati all’interno dei diversi team sono chiavi di successo in molti lavori e le cose rimarranno così fintanto che la tecnologia continuerà a rendere piu facile connettersi attraverso il globo.I datori di lavoro cercano in modo crescente di attrarre gli studenti facilmente capaci di applicare e trasferire i loro skill e saperi in nuovi contesti. Essere pronti per il lavoro in un mondo interconnesso richiede ai giovani di capire le complesse dinamiche. della globalizzazione, essere aperti nei confronti di chi proveniene da contesti differenti, di costruire fiducia nei diversi team e dimostrare rispetto per gli altri.
Educare alle GC può aiutare la occupabilità. La comunicazione efficace e comportamenti appropriati all’interno dei diversi team sono chiavi di successo in molti lavori e le cose rimarranno così fintanto che la tecnologia continuerà a rendere piu facile connettersi attraverso il globo.I datori di lavoro cercano in modo crescente di attrarre gli studenti facilmente capaci di applicare e trasferire i loro skill e saperi in nuovi contesti. Essere pronti per il lavoro in un mondo interconnesso richiede ai giovani di capire le complesse dinamiche. della globalizzazione, essere aperti nei confronti di chi proveniene da contesti differenti, di costruire fiducia nei diversi team e dimostrare rispetto per gli altri.
- Per usare le piattaforme mediatiche in modo efficace e responsabile
 Lungo le due decadi precedenti, radicali trasformazioni n elle tecnologie digitali hanno modellato l’immagine dei giovani nel mondo, le loro interazioni con gli altri e le loro percezioni di se stessi.
Lungo le due decadi precedenti, radicali trasformazioni n elle tecnologie digitali hanno modellato l’immagine dei giovani nel mondo, le loro interazioni con gli altri e le loro percezioni di se stessi.
I network online, i social media e le tecnologie interattive stanno dando origine a nuovi tipi di apprendimento in cui i giovani esercitano un maggiore controllo su cosa e come imparare. Allo stesso tempo le vite digitali dei giovani possono causare loro una disconnessione da se stessi e dal mondo e portarli ad ignorare l’impatto che le loro azioni possono avere sugli altri. In più, mentre la tecnologia aiuta la gente a creare facilmente connessioni in giro per il mondo, il comportamento online suggerisce che la gente tende a “riunirsi”, favorendo le interazioni con un piccolo gruppo di persone con cui hanno molto in comune.
Inoltre, l’accesso ad un illimitata quantità di informazioni va spesso insieme con una insufficiente competenza a proposito dei media, il che significa che i giovani sono facilmente ingannati da notizie partigiane, taroccate o false, In questo contesto, coltivare le GC degli studenti può aiutarli a usare bene gli ambienti digitali, comprendere meglio il mondo in cui vivono e ad esprimere la loro voce online in modo responsabile.
- Per supportare gli obiettivi di sviluppo sostenibile
 Infine, educare alle GC può aiutare a formare nuove generazioni che si impegnino su temi globali e sappiano affrontare sfide sociali, politiche, ambientali ed economiche, L’Agenda 2030 dei SDG riconosce il ruolo critico dell’educazione per raggiungere i suoi obiettivi chiamando tutti i paesi alla realizzazione del suo Obiettivo 4: “assicurare per il 2030 che tutte le persone in apprendimento acquisiscano il sapere e gli skill necessari per promuovere lo sviluppo sostenibile, compresi fra gli altri- attraverso l’educazione per lo sviluppo sostenibile e sostenibili stili di vita- i diritti umani, l’eguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e l’apprezzamento della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.
Infine, educare alle GC può aiutare a formare nuove generazioni che si impegnino su temi globali e sappiano affrontare sfide sociali, politiche, ambientali ed economiche, L’Agenda 2030 dei SDG riconosce il ruolo critico dell’educazione per raggiungere i suoi obiettivi chiamando tutti i paesi alla realizzazione del suo Obiettivo 4: “assicurare per il 2030 che tutte le persone in apprendimento acquisiscano il sapere e gli skill necessari per promuovere lo sviluppo sostenibile, compresi fra gli altri- attraverso l’educazione per lo sviluppo sostenibile e sostenibili stili di vita- i diritti umani, l’eguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e l’apprezzamento della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.
E’ opportuno valutare la Competenza Globale?
Ogni scuola dovrebbe incoraggiare gli studenti a cercare di dare senso ai problemi più pressanti che definiscono i nostri tempi. Alle alte aspettative poste alle scuole sull’ aiutare gli studenti ad avere successo in un contesto crescentemente interconnesso, si può rispondere solo se i sistemi educativi definiscono i loro obiettivi basandosi su un quadro di riferimento solido e se usano differenti tipi di valutazione per riflettere sull’efficacia delle loro  pratiche didattiche. In questo contesto PISA mira a fornire una ampia rassegna degli sforzi dei sistemi educativi per creare ambienti di apprendimento che invitino i giovani a capire il mondo al di là del loro immediato ambiente, ad interagire con altri rispettando i loro diritti e la loro dignità ed ad agire in direzione della costruzione di comunità sostenibili e prospere.
pratiche didattiche. In questo contesto PISA mira a fornire una ampia rassegna degli sforzi dei sistemi educativi per creare ambienti di apprendimento che invitino i giovani a capire il mondo al di là del loro immediato ambiente, ad interagire con altri rispettando i loro diritti e la loro dignità ed ad agire in direzione della costruzione di comunità sostenibili e prospere.
Un fondamentale obiettivo di questo lavoro è supportare decisioni basate su fatti a proposito di come migliorare le risposte di curriculi, insegnanti, valutazioni e scuole alla diversità culturale, al fine di preparare i giovani a diventare cittadini globali.
Come valutare la Competenza Globale?
 La valutazione della Competenza Globale in PISA 2018 è composta da due parti: 1. una valutazione delle conoscenze, 2. un questionario di background.
La valutazione della Competenza Globale in PISA 2018 è composta da due parti: 1. una valutazione delle conoscenze, 2. un questionario di background.
La prima è finalizzata a comprendere le capacità degli studenti di esaminare criticamente i problemi globali, di riconoscere le influenze esterne sulle prospettive e visioni del mondo, di capire come comunicare con gli altri in contesti interculturali e di identificare e paragonare differenti tipi di azione per fare fronte a temi globali ed interculturali.
Nella seconda, il questionario di background, agli studenti si chiederà di riferire quanta famigliarità hanno con temi interculturali, quanto sono sviluppati le loro competenze linguistiche e comunicative, in che misura assumono atteggiamenti come il rispetto per persone con background diversi e quali opportunità hanno a scuola di sviluppare competenze globali.
Le risposte ai questionari scuola ed insegnanti offriranno un quadro comparativo di come i sistemi educativi integrano prospettive globali internazionali ed interculturali nel curriculo e nelle attività di classe.
Presi insieme, valutazione cognitiva e questionari di background pongono le seguenti domande di policy educativa:
- Fino a che livello gli studenti sono capaci di esaminare criticamente temi contemporanei di significato locale, globale ed interculturale?
- Fino a che livello gli studenti sono capaci di comprendere ed apprezzare multiple prospettive culturali, inclusa la propria, e di gestire differenze e conflitti?
- Fino a che livello gli studenti sono preparati ad interagire in modo rispettoso delle differenze culturali?
- Fino a che livello gli studenti si interessano al mondo ed agiscono in modo da fare una significativa differenza nella vita degli altri e da salvaguardare l’ambiente?
- Che diseguaglianze esistono nell’accesso all’educazione per la GC all’interno delle diverse nazioni e fra di loro?
- Che approcci alla educazione interculturale e globale sono più comunemente usati nei sistemi scolastici mondiali?
- Quanto sono preparati gli insegnanti a sviluppare la GC negli studenti?
IL CONCETTO DI COMPETENZA GLOBALE E LE SUE IMPLICAZIONI PER L’EDUCAZIONE
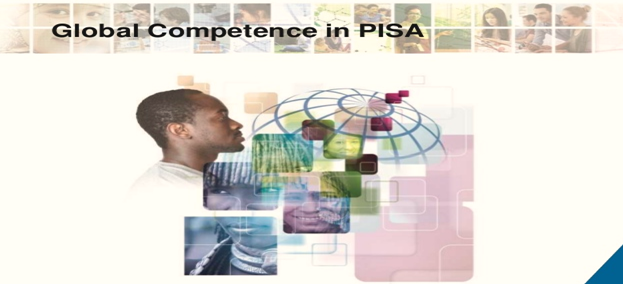
Le 4 dimensioni della competenza globale
 L’educazione alla GC si costruisce a partire da differenti modelli di educazione globale come educazione interculturale, educazione alla cittadinanza globale, educazione per la cittadinanza democratica (UNESCO, 2014a; Council of Europe, 2016a).
L’educazione alla GC si costruisce a partire da differenti modelli di educazione globale come educazione interculturale, educazione alla cittadinanza globale, educazione per la cittadinanza democratica (UNESCO, 2014a; Council of Europe, 2016a).
Nonostante le differenze fra i focus e gli ambiti (differenze culturali o cultura democratica, piuttosto che diritti umani o sostenibilità ambientale), questi modelli condividono l’obiettivo di promuovere la conoscenza del mondo degli studenti e di rinforzarli nella capacità di partecipare ed esprimere i loro punti di vista.
PISA contribuisce ai modelli esistenti, proponendo una nuova prospettiva sulla definizione e valutazione della Competenza Globale. Questi concetti fondamentali e queste linee guida sulla valutazione aiuteranno politici e dirigenti scolastici a creare strumenti per l’apprendimento e curriculi che si approccino alle GC come obiettivi di apprendimento dalle molte facce: cognitive, socio emozionali e civiche. Faciliteranno anche la capacità dei governanti di monitorare i progressi e di assicurare un supporto sistematico e di lungo termine.
“Competenza” è non una mera capacità specifica, ma una combinazione di conoscenze, abilità, attitudini e valori applicati con successo ad incontri faccia a faccia, virtuali o mediati (da immagini nei media es. TV, internet ecc..) con persone che sono percepite provenire da un diverso background culturale, o ad esperienze relative a tematiche globali (come situazioni che richiedono di riflettere su problemi globali che abbiano profonde implicazioni per le generazioni presenti e future e di impegnarsi in proposito).Acquisire GC è un processo che dura una vita – non c’è un singolo momento in cui un individuo diventa completamente competente. PISA valuterà a che punto del processo sono situati i quindicenni e se le loro scuole indirizzano in modo efficace lo sviluppo della GC.
La valutazione di PISA 2018 usa la seguente definizione di GC
La Competenza Globale è la capacità di esaminare temi locali, globali ed interculturali, di comprendere ed apprezzare le prospettive e visioni del mondo degli altri, di impegnarsi in interazioni aperte, appropriate ed efficaci con persone di culture diverse e di agire per il benessere collettivo e lo sviluppo sostenibile.
Questa definizione delinea 4 dimensioni- obiettivo di GC che è necessario applicare con successo nella vita di ogni giorno:
 la capacità di esaminare temi e situazioni di significatività locale globale e culturale (ad esempio povertà, interdipendenza economica, migrazione, diseguaglianza, rischi ambientali, conflitti, differenze culturali e stereotipi);
la capacità di esaminare temi e situazioni di significatività locale globale e culturale (ad esempio povertà, interdipendenza economica, migrazione, diseguaglianza, rischi ambientali, conflitti, differenze culturali e stereotipi);
- la capacità di capire ed apprezzare differenti prospettive e visioni del mondo;
- l’abilità di stabilire relazioni positive con persone con differenti background nazionali, etniche, religiose, sociali, culturali o di genere;
- la capacità e disposizione ad intraprendere azioni costruttive nei confronti dello sviluppo sostenibile e del benessere collettivo;
Queste 4 dimensioni sono fortemente interdipendenti ed anche si sovrappongono, giustificando l’uso del solo termine di GC. Per esempio, gli studenti provenienti da due differenti background che lavorano insieme ad un progetto di scuola dimostrano competenza globale se: si conoscono meglio l’un l’altro (esaminare le differenze culturali), cercano di capire come ciascuno percepisce il proprio ruolo nel progetto e nella prospettiva degli altri (capire le prospettive), negoziano in caso di malinteso e comunicano chiaramente aspettative e sensazioni (interagire in modo aperto, appropriato ed efficace) ed infine fanno il punto su ciò che stanno imparando gli uni dagli altri per migliorare le relazioni sociali nella classe e nella scuola (agire per il bene collettivo).
Definizione di cultura
La “Cultura” è difficile da definire perché i gruppi culturali sono sempre internamente eterogenei e contengono individui che aderiscono ad un arco ampio di credenze e pratiche. Inoltre le credenze e le pratiche culturali che sono più tipiche di ogni gruppo costantemente cambiano e si evolvono nel tempo. Tuttavia si possono individuare distinzioni fra gli aspetti materiali, sociali e oggettivi della cultura cioè fra gli artefatti materiali che sono comunemente usati dai membri di un gruppo culturale (oggetti, cibo e vestiti), le istituzioni sociali del gruppo (lingua, convenzioni comunicative, religione, folklore) e le credenze valori discorsi e pratiche che i membri del gruppo usano come quadro di riferimento per pensare il mondo e relazionarsi ad esso. La cultura è un composto formato da tutti e tre questi aspetti, consistente in una rete di risorse materiali, sociali ed individuali. L’insieme delle risorse culturali è distribuito nell’intero gruppo, ma ogni suo membro usa solo un sottoinsieme degli elementi potenzialmente disponibili. Definire la cultura in questo modo significa che ogni tipo di gruppo sociale può avere la sua cultura distintiva: gruppi su base nazionale, etnica, religiosa, linguistica, occupazionale, generazionale o famigliare La definizione implica anche che ogni individuo appartiene a molti gruppi e perciò ha multiple affiliazioni ed identità. Per quanto tutti appartengano a multiple culture, ciascuno partecipa ad una differente costellazione di culture ed il modo con cui si relaziona a ciascuna dipende almeno in parte dalle prospettive delle altre cui appartiene. In altre parole le affiliazioni culturali si intersecano e ciascuno ha una sua unica posizione culturale. Le affiliazioni culturali della gente sono dinamiche e fluide; cosa pensano li definisce culturalmente ma cambia quando l’individuo si sposta da una posizione all’altra. Queste fluttuazioni dipendono dalla misura in cui ogni contesto sociale si focalizza su una particolare identità e dai bisogni motivazioni interessi ed aspettative nella situazione data.(Council of Europe, 2016a).
Dimensione 1. Esaminare temi di significato locale globale e culturale
 Questa dimensione si riferisce alle pratiche dei soggetti con GC che, per formarsi una propria opinione su un tema globale, combinano sapere efficace sul mondo e ragionamento critico. Le persone che acquisiscono un livello maturo di sviluppo in questa dimensione usano competenze di pensiero di alto livello, come selezionare e soppesare evidenze appropriate per ragionare su sviluppi globali. Gli studenti con GC sanno combinare il sapere disciplinare ed i modi di pensare acquisiti a scuola per porre domande, analizzare dati e argomenti, spiegare fenomeni e sviluppare una posizione su temi locali, globali e culturali. Lo sviluppo di questa dimensione richiede anche una competenza mediatica, definita come l’abilità di accedere a, analizzare e valutare criticamente i messaggi dei media, così come di creare nuovi contenuti. Le persone con GC sono efficaci utilizzatori e creatori di mezzi di comunicazione tradizionali e digitali.
Questa dimensione si riferisce alle pratiche dei soggetti con GC che, per formarsi una propria opinione su un tema globale, combinano sapere efficace sul mondo e ragionamento critico. Le persone che acquisiscono un livello maturo di sviluppo in questa dimensione usano competenze di pensiero di alto livello, come selezionare e soppesare evidenze appropriate per ragionare su sviluppi globali. Gli studenti con GC sanno combinare il sapere disciplinare ed i modi di pensare acquisiti a scuola per porre domande, analizzare dati e argomenti, spiegare fenomeni e sviluppare una posizione su temi locali, globali e culturali. Lo sviluppo di questa dimensione richiede anche una competenza mediatica, definita come l’abilità di accedere a, analizzare e valutare criticamente i messaggi dei media, così come di creare nuovi contenuti. Le persone con GC sono efficaci utilizzatori e creatori di mezzi di comunicazione tradizionali e digitali.
Esaminare temi di significato globale: un esempio
Nel suo corso di storia una studentessa studia l’industrializzazione e la crescita economica nei Paesi in via di sviluppo. Impara che molte ragazze della sua età lavorano in cattive condizioni in fabbrica fino a dieci ore al giorno, invece di andare a scuola. La sua insegnante incoraggia ogni studente a portare in classe un capo di abbigliamento ed ad osservare l’etichetta per vedere dove è stato fabbricato. La studentessa è sorpresa nel notare che la maggior parte proviene dal Bangladesh. La studentessa si chiede in quali condizioni i suoi vestiti sono stati fabbricati. Guarda ai siti web di molte marche presenti nei negozi della strada commerciale di dove abita per vedere se possono dirle qualcosa sugli standard e le politiche delle fabbriche. Scopre che alcune marche di abbigliamento sono più attente di altre al rispetto dei diritti umani nelle loro fabbriche e scopre anche che alcune invece hanno una lunga storia di condizioni disastrose di lavoro. Legge differenti articoli di giornali sul tema e guarda un breve documentario su YouTube. Sulla base di ciò che scopre, inizia a comprare abiti del commercio equo e solidale e diventa una sostenitrice delle manifatture eticamente responsabili.
Dimensione 2. Capire ed apprezzare le prospettive e le visioni del mondo degli altri
 Questa dimensione sottolinea il fatto che le persone con GC vogliono e sono capaci di considerare i problemi globali e le prospettive ed i comportamenti degli altri da differenti punti di vista. Via via che gli individui acquisiscono conoscenze sulla storia, sui valori, sugli stili di comunicazione, sulle credenze e le pratiche di altre culture, acquisiscono gli strumenti per riconoscere che le loro prospettive e comportamenti sono modellati da influenze multiple, che non sono sempre completamente consapevoli di queste influenze e che altri hanno visioni del mondo che sono profondamente diverse dalle proprie.
Questa dimensione sottolinea il fatto che le persone con GC vogliono e sono capaci di considerare i problemi globali e le prospettive ed i comportamenti degli altri da differenti punti di vista. Via via che gli individui acquisiscono conoscenze sulla storia, sui valori, sugli stili di comunicazione, sulle credenze e le pratiche di altre culture, acquisiscono gli strumenti per riconoscere che le loro prospettive e comportamenti sono modellati da influenze multiple, che non sono sempre completamente consapevoli di queste influenze e che altri hanno visioni del mondo che sono profondamente diverse dalle proprie.
L’impegno ad assumere differenti prospettive e visioni del mondo richiede alle persone di esaminare le origini e le implicazioni degli assunti propri e di quelli altrui. A sua volta ciò implica un profondo rispetto ed interesse per ciò che l’altro è, per il suo concetto della realtà e le sue emozioni. Gli individui con questa competenza apprezzano le connessioni (diritti umani fondamentali e bisogni, esperienze comuni) che li rendono capaci di gettare un ponte fra le differenze e creare un terreno comune. Mantengono la loro identità culturale, ma sono simultaneamente consapevoli dei valori culturali e delle credenze delle persone intorno a loro. Riconoscere la posizione o le credenze di un altro non significa necessariamente accettarle. Tuttavia l’abilità di vedere attraverso “un altro filtro culturale” offre opportunità di approfondire e porre in discussione le proprie prospettive e così prendere decisioni mature, quando si tratta con gli altri.
Capire le prospettive e le visioni del mondo: un esempio
Uno studente nota che certi membri della sua classe hanno smesso di pranzare. Quando chiede gli dicono che stanno partecipando ad un periodo di digiuno. Lo studente è curioso e fa altre domande. Per quanto digiuneranno? Quando possono mangiare? Cosa possono mangiare? Quale è il significato religioso del digiuno? Lo studente apprende che per i suoi compagni il digiuno è una cosa che fanno ogni anno insieme con le loro famiglie e la loro comunità. Impara anche che per i compagni il digiuno è importante perché dimostra il loro controllo sul corpo. Lo studente riflette sul significato di ciò. Per quanto lui non digiuni riconosce che i temi di comunità, sacrificio e trascendenza dalla materia sono comuni a molte religioni, compresa la propria. Riconosce che differenti gruppi possono attribuire lo stesso significato a pratiche differenti. Inoltre chiede ai suoi compagni se può unirsi a loro nel digiuno, per fare esperienza di cosa significa per loro digiunare. I suoi compagni acconsentono volentieri e lo invitano ad unirsi alla loro famiglia alla sera quando rompono il digiuno. Anche se lo studente non attribuisce lo stesso significato al digiuno attraverso questa esperienza, capisce meglio le prospettive dei suoi compagni ed il suo rispetto per la diversità religiosa aumenta.
Dimensione 3. Impegnarsi in aperte, appropriate ed efficaci interazioni fra le culture
 Questa dimensione descrive cosa i soggetti con GC sono capaci di fare quando interagiscono con persone di altre culture. Capiscono le regole culturali, gli stili di interazione ed i gradi di formalità dei contesti culturali e possono in tal modo adattare flessibilmente il loro comportamento e le loro modalità di comunicazione. Questa dimensione genera apprezzamento verso il dialogo rispettoso degli altri, desiderio di capirli e sforzi per includere i gruppi marginalizzati. Ciò enfatizza la capacità di interagire con gli altri attraverso le differenze, in modi che sono aperti, appropriati ed efficaci. Il termine interazioni aperte significa relazioni in cui tutti i partecipanti dimostrano sensibilità, curiosità e volontà di impegnarsi con gli altri e assumere le loro prospettive. Il termine appropriate si riferisce ad interazioni che rispettano le norme culturali di ambedue le parti. Nella comunicazione efficace infine tutti i partecipanti sono capaci di farsi comprendere e di comprendere gli altri.
Questa dimensione descrive cosa i soggetti con GC sono capaci di fare quando interagiscono con persone di altre culture. Capiscono le regole culturali, gli stili di interazione ed i gradi di formalità dei contesti culturali e possono in tal modo adattare flessibilmente il loro comportamento e le loro modalità di comunicazione. Questa dimensione genera apprezzamento verso il dialogo rispettoso degli altri, desiderio di capirli e sforzi per includere i gruppi marginalizzati. Ciò enfatizza la capacità di interagire con gli altri attraverso le differenze, in modi che sono aperti, appropriati ed efficaci. Il termine interazioni aperte significa relazioni in cui tutti i partecipanti dimostrano sensibilità, curiosità e volontà di impegnarsi con gli altri e assumere le loro prospettive. Il termine appropriate si riferisce ad interazioni che rispettano le norme culturali di ambedue le parti. Nella comunicazione efficace infine tutti i partecipanti sono capaci di farsi comprendere e di comprendere gli altri.
Interagire in modo aperto efficace ed appropriato con le differenze culturali: un esempio
Jo ed Ai stanno collaborando ad un progetto scolastico con uno studente di un altro Paese: Mike. Gli studenti mettono a punto una video chat su una piattaforma web per fare un brainstorming, ma, al tempo convenuto per il meeting, non trovano Mike online. Quando, alcune ore più tardi, gli studenti fanno in modo di connettersi di nuovo sulla piattaforma web, Jo si lamenta del fatto che non essere riusciti a vedersi al primo incontro non è un buon inizio e si arrabbia quando non riceve alcuna spiegazione da Mike, che rimane silenzioso dall’altra parte della linea. A questo punto Ai dimostra le sue competenze globali, perché con successo depotenzia il conflitto. Sa che il silenzio viene usato in alcune culture come una strategia per gestire le aggressioni che si percepiscono e non è necessariamente un’ ammissione di colpevolezza o un segno di indifferenza. E’ anche consapevole che alcune persone si astengono dal parlare direttamente per paura di un contrasto che può offendere i sentimenti dell’altro e minacciare la loro relazione. Sospende così il suo giudizio intorno al comportamento di Mike e gli chiede gentilmente perché non l’hanno trovato online. Mike risponde che probabilmente si è trattato di un fraintendimento circa l’ora dell’appuntamento poiché il Paese di Jo e Ai ha spostato l’ora legale la notte prima, cosa che il suo Paese non ha fatto. Grazie all’intervento di Ai gli studenti hanno potuto ridere del piccolo incidente e cominciare a lavorare al loro progetto.
Dimensione 4. Agire per il benessere collettivo e lo sviluppo sostenibile
 Questa dimensione si focalizza sul ruolo dei giovani come membri attivi e responsabili della società e si riferisce alla prontezza dei soggetti nel rispondere ad una situazione o problema locale, globale o interculturale. Questa dimensione riconosce che i giovani hanno molteplici ambiti di influenza che vanno dal personale- locale al digitale- globale. Le persone competenti creano opportunità per intraprendere azioni informate e riflessive e fanno sentire le loro voci. Intraprendere azioni può implicare difendere un compagno la cui dignità è a repentaglio, iniziare una campagna globale attraverso i media a scuola o diffondere un pensiero personale sulla crisi dei rifugiati attraverso i social media. Le persone globalmente competenti sono impegnate a migliorare le condizioni di vita delle loro comunità ed anche a costruire un mondo più giusto, pacifico, inclusivo ed attento all’ambiente.
Questa dimensione si focalizza sul ruolo dei giovani come membri attivi e responsabili della società e si riferisce alla prontezza dei soggetti nel rispondere ad una situazione o problema locale, globale o interculturale. Questa dimensione riconosce che i giovani hanno molteplici ambiti di influenza che vanno dal personale- locale al digitale- globale. Le persone competenti creano opportunità per intraprendere azioni informate e riflessive e fanno sentire le loro voci. Intraprendere azioni può implicare difendere un compagno la cui dignità è a repentaglio, iniziare una campagna globale attraverso i media a scuola o diffondere un pensiero personale sulla crisi dei rifugiati attraverso i social media. Le persone globalmente competenti sono impegnate a migliorare le condizioni di vita delle loro comunità ed anche a costruire un mondo più giusto, pacifico, inclusivo ed attento all’ambiente.
Agire per il benessere collettivo e lo sviluppo sostenibile: un esempio
Un gruppo di studenti decide di iniziare una campagna di consapevolezza ambientale sui modi con cui la loro scuola contribuisce allo spreco ed all’inquinamento locale e globale. Con l’aiuto dei loro insegnanti organizzano una serie di conversazioni su come ridurre lo spreco ed il consumo di energia. Inoltre predispongono e distribuiscono in modo strategico poster informativi che aiutino gli studenti a fare scelte migliori quando acquistano e scartano. Inoltre collaborano con i rappresentanti degli studenti e gli amministratori della scuola per introdurre, fra gli obiettivi della scuola, l’uso di cassoni di riciclaggio e l’assunzione di strategie per la conservazione dell’energia.
I 4 PILASTRI DELLA COMPETENZA GLOBALE: CONOSCENZE, ABILITA’, ATTITUDINI E VALORI

Le quattro dimensioni della GC sono supportate da quattro fattori inseparabili: conoscenze, abilità, attitudini e valori. Per esempio, l’esame di un problema globale richiede la sua conoscenza, l’abilità di trasformare questa consapevolezza in una consapevolezza più profonda, e l’attitudine ed i valori per riflettere sul tema da molteplici prospettive, tenendo a mente l’interesse di tutte le parti coinvolte.
Un’educazione efficace alla GC dà agli studenti l’opportunità di mettere in moto ed usare le quattro dimensioni insieme, quando scambiano le loro idee su un tema globale dentro e fuori la scuola o interagiscono con persone di background culturali differenti. Ad esempio impegnandosi in discussioni, mettendo in dubbio i diversi punti di vista, chiedendo spiegazioni o identificando direzioni ulteriori per analisi più profonde o azioni.
Una comunità scolastica che desidera sviluppare la GC dovrebbe focalizzarsi su chiari e gestibili obiettivi di apprendimento. Questo significa impegnare tutti gli educatori a riflettere sull’insegnamento di argomenti che siano significativi a livello globale, sui tipi di competenze che rinforzano una comprensione più profonda del mondo e facilitano interazioni rispettose in contesti multiculturali e sulle attitudini ed i valori che guidano un apprendimento autonomo e ispirano azioni responsabili.
Questa sezione offre una descrizione generale dei contenuti di queste 4 dimensioni che sono necessarie agli individui per essere globalmente competenti. I politici, i dirigenti scolastici e gli insegnanti possono fare riferimento a questa sezione per costruire strategie al fine di definire e valutare le GC. Tuttavia questa descrizione non pretende di essere definitiva o onnicomprensiva (altre prospettive possono porre maggiore enfasi su altri aspetti, quali l’inquadramento dei problemi o la gestione delle emozioni), La definizione e la assunzione come obiettivi di capacità ed attitudini dovrebbe anche essere adattata al contesto nel quale la scuola opera.
1° pilastro: conoscenza del mondo e di altre culture
 La GC è supportata sia dalla conoscenza di temi globali che influenzano la vita a livello locale ed a livello mondiale, sia dalla conoscenza interculturale, cioè il sapere sulle somiglianze, differenze e relazioni fra le culture. Questa conoscenza aiuta le persone a sfidare stereotipi e fraintendimenti su altri Paesi e altri popoli e ad opporsi, così, all’intolleranza ed a una rappresentazione ipersemplificata del mondo.
La GC è supportata sia dalla conoscenza di temi globali che influenzano la vita a livello locale ed a livello mondiale, sia dalla conoscenza interculturale, cioè il sapere sulle somiglianze, differenze e relazioni fra le culture. Questa conoscenza aiuta le persone a sfidare stereotipi e fraintendimenti su altri Paesi e altri popoli e ad opporsi, così, all’intolleranza ed a una rappresentazione ipersemplificata del mondo.
Temi globali sono quelli che coinvolgono tutti indipendentemente dalla nazione o dal gruppo sociale. Vanno dal commercio alla povertà, ai diritti umani, alla geopolitica e all’ambiente. I temi globali rivelano come le differenti regioni del mondo siano interconnesse, facendo luce sulle diversità e le somiglianze fra le diverse esperienze. Per esempio, l’inquinamento che si registra in un posto colpisce la fascia di ozono anche altrove, le inondazioni in aree agricole rovinano non solo l’ambiente e le economie locali ma colpiscono anche i mercati in altre parti del mondo e causano ondate di immigrazione. I temi globali sono anche temi locali; sono locali nella loro portata, ma le comunità locali ne fanno esperienza in modi diversi.
Poiché i temi globali emergono quando interessi ecologici e socioeconomici attraversano i confini, i problemi (le situazioni) interculturali sorgono dall’interazione di popoli con background culturali diversi. In questa interazione il modo di pensare, credere, sentire ed agire degli uni sono interpretati dagli altri. Il processo può essere agevole, se non vi sono grandi differenze fra le culture e gli individui sono pronti a conoscere le differenze e ad accettarle. Ma le interazioni interculturali possono anche fronteggiare una cattiva comunicazione e comprensione. Nel peggiore dei casi questi fraintendimenti degenerano in stereotipi negativi discriminazione e conflitti violenti. Più che in altri domini del sapere,la GC richiede di impegnarsi su temi controversi Più che in altri domini del sapere,la GC richiede di impegnarsi su temi controversi Le scuole possono offrire uno spazio sicuro in cui gli studenti possono esplorare temi globali complessi e controversi che incontrano nei media e nella propria esperienza.
La lista di temi rilevanti globali o interculturali che possono essere presentati ai bambini ed ai giovani nelle scuole è lunga. Ci sono stati recenti tentativi di sistematizzare questi complessi gruppi di temi in una sequenza coerente di lezioni e materiali di apprendimento per ogni livello del curriculo.
Un curriculo dovrebbe prestare attenzione ai seguenti quattro ambiti di conoscenza:
- cultura e relazioni interculturali,
- sviluppo socioeconomico ed interdipendenza,
- sostenibilità ambientale,
- istituzioni globali, conflitti e diritti umani.
L’insegnamento di questi quattro ambiti dovrebbe illustrare le differenze fra le opinioni e le prospettive, mettendo in discussione concetti come “verità” e “informazione”. Per esempio, mentre esamina le diseguaglianze economiche del mondo, l’insegnante può spiegare che ci sono diverse interpretazioni di ciò che lo sviluppo implica e significa, incitando gli studenti a misurare lo sviluppo secondo diversi sistemi di misura.
- Il primo ambito chiave della conoscenza per le GC è relativa alle molteplici espressioni di cultura e relazioni interculturali come linguaggio, arte, conoscenza, tradizioni e norme. Acquisire conoscenza in questo ambito può aiutare i giovani a diventare consapevoli della propria identità culturale, a capire le differenze e somiglianze fra e dentro le culture ed infine incoraggiarli a valutare l’importanza di proteggere le differenze culturali e le diversità. Quando si impegnano ad apprendere sulle altre culture e sulle differenze fra gli individui, gli studenti iniziano a riconoscere molteplici complesse identità e ad evitare di classificare le persone attraverso singoli segni di identità: nero, bianco, donna, povero. Gli studenti possono acquisire conoscenza in questo dominio riflettendo sulla propria identità culturale e su quella dei pari, analizzando stereotipi comuni verso la gente nella loro comunità o studiando casi che illustrano o conflitti o integrazioni di successo fra differenti comunità.
- Il secondo ambito, quello dello sviluppo socio-economico e dell’interdipendenza fanno riferimento allo studio di modelli di sviluppo in differenti regioni del mondo, con un focus sui legami e le interdipendenze fra le società e le economie.Gli studenti possono analizzare a differenti livelli di complessità ed in modi appropriati le molte forme della globalizzazione, come le migrazioni internazionali, la produzione transnazionale, i marchi e le tecnologie globali. Facendo così, gli studenti possono cominciare a rendersi conto di come i processi locali, nazionali e globali congiuntamente definiscono i modelli di sviluppo dei paesi e le diseguaglianze fra le opportunità disponibili per i diversi individui.
- Il terzo ambito si riferisce all’esigenza che gli studenti abbiano un solido fondamento sulle questioni dell’ambiente per promuovere e supportare la sostenibilità. Svolgere attività nell’ambito della sostenibilità ambientale li aiuta a comprendere i complessi sistemi e le politiche coinvolti nel bisogno e nell’uso delle risorse naturali.
- Il quarto ambito di conoscenze relativo alle GC si focalizza sulle istituzioni formali e non formali che supportano le relazioni pacifiche fra i popoli ed il rispetto dei diritti umani fondamentali Gli studenti possono apprendere come sono state fondate istituzioni globali come l’ ONU, possono riflettere sulla contestata natura del governo globale in un mondo con relazioni di potere molto sbilanciate, possono passare in rivista cause e soluzioni degli attuali storici conflitti fra Paesi, etnie o gruppi sociali ed infine possono esaminare gli spazi e le opportunità esistenti per i giovani di giocare un ruolo attivo nella società, di prendersi responsabilità e di esercitare i propri diritti. Acquisire una conoscenza approfondita in questo campo serve ai giovani per sviluppare valori come pace, non discriminazione, eguaglianza, giustizia, non violenza, tolleranza e rispetto.
2° pilastro: competenze per capire il mondo e per agire
 Le competenze globali si costruiscono anche sulla base di specifiche capacità cognitive, di comunicazione e socio-emozionali, che significa capacità di sviluppare un modello di pensiero complesso e ben organizzato (nel caso di capacità cognitive) o di comportamento, per ottenere un particolare obiettivo. La GC richiede numerose capacità (skills) incluso il ragionare utilizzando l’informazione e la comunicazione in un contesto interculturale, assumere delle prospettive, risolvere i conflitti ed essere capaci di adattarsi.
Le competenze globali si costruiscono anche sulla base di specifiche capacità cognitive, di comunicazione e socio-emozionali, che significa capacità di sviluppare un modello di pensiero complesso e ben organizzato (nel caso di capacità cognitive) o di comportamento, per ottenere un particolare obiettivo. La GC richiede numerose capacità (skills) incluso il ragionare utilizzando l’informazione e la comunicazione in un contesto interculturale, assumere delle prospettive, risolvere i conflitti ed essere capaci di adattarsi.
Gli studenti dotati di GC sono capaci di ragionare con informazioni provenienti da differenti fonti quali libri di testo, pari, adulti, media digitali e tradizionali. Possono autonomamente identificare i loro bisogni di informazione e selezionare appositamente le fonti sulla base della loro rilevanza ed affidabilità.Usano un approccio logico, sistematico e sequenziale per esaminare le informazioni in un testo o in un altro tipo di media esaminando connessioni e discrepanze. Possono valutare il valore, la validità e la affidabilità di qualsiasi materiale sulla base della sua consistenza interna e la sua consistenza con le evidenze ed il sapere e l’ esperienza di ciascuno. Gli studenti con GC si pongono domande e riflettono sulle ragioni, gli scopi ed i punti di vista degli autori delle fonti, sulle tecniche usate per attrarre l’attenzione, sull’uso delle immagini, dei suoni e del linguaggio per trasmettere il significato e sulle diverse interpretazioni possibili fornite da soggetti diversi.
Gli studenti con GC sono capaci di comunicare in modo efficace e rispettoso con persone che hanno background differenti. La comunicazione efficace richiede di essere capaci di esprimersi in modo chiaro, sicuro e senza trascendere, anche quando si esprime un profondo disaccordo. La comunicazione rispettosa richiede di capire le aspettative e le prospettive dei diversi uditori ed utilizzare questa comprensione per andare incontro ai bisogni di chi ascolta. La comunicazione rispettosa controlla e chiarifica i significati delle parole e delle frasi, quando ci si impegna in un dialogo interculturale. Parlare più di una lingua è chiaramente un bene per una efficace comunicazione interculturale. Una comunicazione gradevole in un contesto interculturale facilita anche l’ascolto attivo; ciò significa guardare non solo a ciò che si sta dicendo ma anche a come lo si dice, attraverso l’uso della voce ed il linguaggio del corpo che la accompagna. Gli studenti competenti sono abili oratori che sanno usare la voce ed il linguaggio del corpo in modo efficace; quando discutono di problemi globali esprimono e motivano una personale opinione e persuadono gli altri a seguire un particolare percorso di azione.
Assumere prospettive si riferisce alle competenze sociali e cognitive di cui gli individui abbisognano per capire ciò che gli altri pensano e sentono. E’ la capacità di identificare ed assumere punti di vista in conflitto, di “mettersi nei panni di qualcun altro”: ciò comporta non solo immaginare il punto di vista di un altro, ma anche capire come varie prospettive si relazionano le une con le altre Capire le prospettive degli altri facilita interpretazioni più mature e tolleranti della differenze fra i gruppi.
Gli studenti con GC si approcciano ai conflitti in un modo costruttivo riconoscendo che è un processo che va gestito piuttosto che cercare di negarlo. Prendere parte attiva nella gestione e soluzione dei conflitti richiede ascolto e ricerca di soluzioni comuni. I modi possibili di indirizzare i conflitti sono: analizzare i problemi, i bisogni e gli interessi chiave (potere, riconoscimento del merito, divisione del lavoro, equità), identificare le origini del conflitto e le prospettive di quelli che vi sono coinvolti, riconoscere che le parti possono differire quanto a status o potere, identificare le aree di accordo e disaccordo, collocare il tutto in un’altra cornice, gestire e regolare le emozioni, interpretare i cambiamenti nelle emozioni e nelle motivazioni sottese proprie e degli altri, avere a che fare con lo stress, l’ansietà e l’insicurezza proprie e degli altri, decidere le priorità relativamente ai bisogni ed agli obiettivi, decidere sui possibili compromessi e sulle circostanze in cui raggiungerli. Tuttavia i modi per gestire e risolvere i conflitti possono variare a seconda delle aspettative delle società; così non tutti sono d’accordo sui passi sopra delineati.
Adattabilità si riferisce all’abilità di adattare pensieri e comportamenti al contesto culturale prevalente o di riconoscere situazioni e contesti che potrebbero presentare nuove domande o sfide. Gli individui che acquisiscono questa competenza sono capaci di maneggiare i sentimenti relativi agli shock culturali come frustrazione, stress ed alienazione in situazioni ambigue causate da nuovi ambienti. Chi apprende in modo adattabile può più facilmente sviluppare relazioni personali di lungo termine con gente di altre culture e rimanere resilienti in circostanze mutate.
Integrare temi globali ed interculturali nel curriculo
La ricerca sulla educazione globale tende a focalizzarsi sui corsi di “studi sociali” e di lingue straniere, spesso nei livelli superiori. Però i temi locali, globali e multiculturali che gli studenti dovrebbero studiare per assumere responsabilità ed agire in proposito passano attraverso tutti i livelli di studio e tutte le discipline. Perché l’educazione globale passi dall’astrazione all’azione, molti raccomandano di integrare i temi e gli argomenti globali negli argomenti esistenti In pratica, alcune nazioni stanno avendo un approccio duplice per il quale i contenuti di conoscenza relativi alla GC sono sia integrati nel curriculo esistente, che insegnati in specifiche materie e corsi (per esempio Educazione ai diritti umani). Gli studenti possono giungere a capire i temi locali, globali ed interculturali attraverso le diverse età cominciando dall’infanzia, qualora tali temi siano presentati in modi adeguati al loro sviluppo.
Il modo in cui l’insegnante colloca un argomento nel curriculo può contribuire in modo significativo alla creazione di GC. Predisponendo un argomento da approfondire con i suoi studenti, l’insegnante può prendere in considerazione il modo in cui esso si indirizza alle dinamiche locali e globali e approfondirlo può aiutare gli studenti a comprendere ampi modelli globali e l’impatto sul loro ambiente locale. Per esempio un insegnante di matematica potrebbe invitare gli studenti a decidere se le funzioni esponenziali o lineari sono adatte a misurare la crescita demografica mondiale o un insegnante di musica può analizzare quanto oggi l’hiphop si esprima in modi differenti in giro per il mondo.
Per evitare il rischio che l’educazione globale diventi un curriculo piglia tutto, gli insegnanti devono avere idee chiare circa i temi globali ed interculturali sui quali vogliono che gli studenti riflettano. Gli insegnanti hanno bisogno di ricercare argomenti in modo collaborativo e di pianificare attentamente il curriculo, dando agli studenti molteplici possibilità di imparare intorno ad un insieme fondamentale di argomenti che crescano di complessità per tutto il periodo della loro istruzione. Le comunità professionali di apprendimento possono essere molto efficaci nell’impegnare tutti gli insegnanti e nel facilitare la collaborazione e l’apprendimento fra pari. Per esempio Lee ed altri mostrano che insegnanti altamente motivati in Tailandia hanno seguito un corso di GC promosso dal Ministero dell’Educazione e quindi hanno creato comunità professionale di apprendimento nelle loro scuole, per impegnare altri insegnanti, aiutarli ad integrare argomenti globali ed interculturali nei loro corsi e per promuovere progetti a livello di scuola.
L’insegnamento sulle culture minoritarie in differenti aree di studio richiede attenzione circa i contenuti dei profili dei diversi gruppi etnici e razziali. I curriculi dovrebbero promuovere l’integrazione di altri popoli, luoghi e prospettive nel lavoro di ogni giorno delle classi nel corso dell’anno, piuttosto che usare un approccio da turista che offra agli studenti solo un’occhiata superficiale sulla vita in altri paesi nel presente e nel passato./
Anche i libri di testo ed altri materiali possono distorcere le differenze etniche e culturali. Gli insegnanti ed i loro studenti dovrebbero anche analizzare criticamente i loro libri di testo ed i materiali che usano e se necessario compensare la loro inadeguatezza.
Connettere argomenti globali ed interculturali alla realtà, ai bisogni ed al contesto dei gruppi di apprendimento è un approccio metodologico efficace per renderli importanti per gli adolescenti.
La gente impara meglio e si impegna di più quando i contenuti la riguardano e quando si possono vedere i parallelismi fra i temi globali ed il proprio immediato contesto. Per esempio gli studenti possono diventare consapevoli dei rischi relativi al cambio climatico studiando gli effetti che i fenomeni naturali hanno sulla loro comunità. Capitalizzare l’esperienza locale e l’esperienza dei giovani in modo culturalmente responsabile è particolarmente importante quando si insegna a giovani meno privilegiati o immigrati.
3° pilastro: attitudini all’apertura e al rispetto verso persone provenienti da contesti culturali diversi e apertura mentale alla globalità

La GC è sostenuta da disposizioni fondamentali ovvero attitudini. Attitudine si riferisce alla disposizione mentale che un individuo adotta verso una persona, un gruppo, una istituzione, un tema un comportamento un simbolo. Questa disposizione mentale integra credenze, valutazioni, sentimenti e tendenze a comportarsi in un modo determinato. Un comportamento improntato alla GC richiede una attitudine all’apertura verso le persone con altri background culturali, al rispetto per le differenze culturali ed una consapevolezza globale del fatto di essere cittadino del mondo con impegni ed obblighi verso il pianeta e gli altri, indipendentemente dal proprio particolare background culturale o nazionale Tali attitudini possono essere rinforzate esplicitamente attraverso un insegnamento partecipato o centrato sull’allievo ed anche implicitamente attraverso un curriculo caratterizzato da pratiche corrette e da un clima di scuola che sia accogliente per tutti gli studenti.
L’apertura verso persone provenienti da altri background culturali comporta sensibilità, curiosità e voglia di impegnarsi con altre persone ed altre prospettive a livello mondiale. Richiede una volontà attiva di ricercare e di abbracciare le opportunità di impegnarsi con persone di altri background culturali, di scoprire ed apprendere le loro prospettive culturali e come interpretano fenomeni famigliari e non, nonché le loro convenzioni linguistiche e culturali. Un’altra importante caratteristica di chi impara in modo aperto è la volontà di sospendere i propri valori culturali, credenze e comportamenti quando si interagisce con gli altri e di non credere che essi siano i soli corretti. La attitudine all’ apertura verso la diversità culturale deve essere distinta dal semplice fatto di essere interessato a collezionare esperienze esotiche per il proprio esclusivo piacere o beneficio. Piuttosto l’apertura interculturale viene dimostrata attraverso la volontà di impegnarsi, cooperare ed interagire su una posizione di parità con coloro che hanno affiliazioni culturali differenti dalle proprie.
Il rispetto consiste in uno sguardo positivo o nella stima verso qualcuno o qualcosa, sulla base della buona opinione del loro valore. In questo quadro, il rispetto presuppone la dignità di tutti gli esseri umani e il loro inalienabile diritto a scegliere le loro affiliazioni, credenze, opinioni o pratiche. Essere rispettosi delle differenze culturali non richiede di minimizzare o ignorare le differenze profonde e significative che potrebbero esistere fra se stessi e gli altri, né richiede di essere d’accordo con le credenze degli altri, di adottarle o di convertirvisi. Il rispetto per gli altri ha limiti che sono stabiliti dai principi della umana dignità. Per esempio non dovrebbe essere accordato rispetto a credenze, opinioni o stili di vita e pratiche che minino o violino la dignità degli altri. Il concetto di rispetto dovrebbe essere distinto da quello di tolleranza. La tolleranza può, in certi contesti, semplicemente sopportare la differenza. Rispetto è un concetto meno ambiguo e più positivo. E’ basato sul riconoscimento della dignità dei diritti e della libertà degli altri, in una relazione di eguaglianza.
Mentalità globale è definita come “una visione del mondo nella quale vediamo noi stessi connessi con la comunità mondiale e ci sentiamo responsabili per i suoi membri”. Una persona così caratterizzata si preoccupa per gli altri che vivono in altre parti del globo, così come sente la responsabilità morale di migliorare le condizioni degli altri, indipendentemente dalla distanza o dalla differenza culturale. Ha a cuore le generazioni future e così agisce in modo da preservare l’integrità ambientale del pianeta. Esercita la sua azione e la sua voce pur con la consapevolezza critica del fatto che altri potrebbero avere una visione differente di ciò di cui l’umanità abbisogna, è aperto a riflettervi ed a cambiare la sua visione, quando conosce prospettive diverse. Piuttosto che pensare che tutte le differenze possono essere eliminate, lotta per creare gli spazi per vivere con dignità in modi differenti.
Pedagogie per promuovere le competenze globali
Diverse pedagogie centrate sullo studente possono aiutare gli studenti a sviluppare senso critico in relazione ai problemi globali, comunicazione rispettosa, capacità di gestire i conflitti, capacità di assumere prospettive ed adattabilità.
Il Project work cooperativo basato sul gruppo può migliorare le capacità di ragionamento e collaborazione. Prevede infatti compiti basati su argomenti o temi adatti per vari livelli ed età, nei quali gli obiettivi ed i contenuti sono negoziati fra tutti i partecipanti e chi apprende deve creare i propri materiali che vengono presentati e valutati assieme. Per cooperare efficacemente le persone che apprendono devono sentirsi sicure e a loro agio e gli obiettivi debbono essere chiaramente definiti. Coloro che partecipano a compiti cooperativi comprendono subito che, per essere efficienti, devono essere rispettosi, attenti, onesti ed empatici. I project work possono davvero unire gli studenti al di la dei confin. Per esempio Global Cities ha creato un programma di scambio digitale –Global Scholar– attraverso il quale a studenti di 26 nazioni viene data l’opportunità di lavorare in una e-classe intorno al mondo; Harvard Project Zero ha collegato studenti di 57 nazioni.
Gli studenti possono dare voce a differenze, pregiudizi e credenze culturalmente determinate attraverso discussioni organizzate in classe. Per stimolare la discussione l’insegnante generalmente usa un video clip che stimoli il pensiero, oppure una immagine o un testo Gli studenti possono presentare prove a supporto, commentare ed esprimere i loro punti di vista. La discussione di classe è per natura uno sforzo interattivo ed i dialoghi riflessivi generano un ascolto proattivo e la capacità di rispondere alle idee esposte dai pari. Scambiando idee in classe, gli studenti imparano che non c’è una sola risposta giusta ad un problema che deve essere memorizzata e presentata, apprendono a capire le ragioni per cui gli altri hanno visioni differenti e diventano capaci di riflettere sulle origini delle proprie credenze.
I dibattiti strutturati costituiscono uno specifico format di discussione in classe usati sempre di più nella istruzione superiore ed all’università, come un modo per innalzare la consapevolezza degli studenti su temi globali ed interculturali e per permettere loro di praticare le loro capacità di comunicazione ed argomentazione. In questo format agli studenti si danno istruzioni per far parte di un gruppo che sostiene o contraddice un punto di vista in discussione – ad esempio se Internet debba essere censurato oppure se ospitare una Olimpiade sia un buon investimento. E’ spesso utile per uno studente sostenere opinioni diverse dalle proprie.
Service Learning è un altro strumento che può aiutare gli studenti a sviluppare numerose competenze globali attraverso l’esperienza di vita reale. Esso richiede di partecipare ad attività organizzate basate su cio che si è imparato in classe e che vadano a beneficio della comunità. Dopo le attività, agli studenti si richiede di riflettere criticamente sulla loro esperienza di servizio al fine di ottenere una maggiore comprensione dei contenuti del corso e di valorizzare il senso del loro ruolo nella società in relazione a temi civici, sociali, economici e politici. Service Learning è fortemente legato al curriculo e differisce sia da altri tipi di esperienze educative nella comunità che dal volontariato Attraverso Service Learning gli studenti non solo “servono per imparare” il che è apprendimento applicato, ma anche “imparano per servire”.
L’approccio Story Circle è stato usato in molte classi nel mondo per fare praticare agli studenti le loro competenze interculturali, incluso il rispetto, l’empatia e l’ autoconsapevolezza culturale. Gli studenti in gruppi di 5 o 6 a turno condividono una storia di 3 minuti basata su specifici suggerimenti come ”Parlaci della tua prima esperienza quando hai incontrato qualcuno diverso da te”. Dopo che tutti gli studenti del gruppo hanno condiviso le loro esperienze gli studenti a turno condividono i più significativi passi dei racconti in una attività di flash back.
Altri tipi di impegni interculturali prevedono simulazioni, interviste, giochi di ruolo ed altri giochi on line (v. Anna Lindh Foundation, 2017; Berardo and Deardorff, 2012; Council of Europe, 2015; Fantini, 1997; Seelye, 1996; Storti, 2017; Stringer and Cassiday, 2009).
4° pilastro: Valorizzazione della dignità umana e delle diversità
 I valori vanno al di là delle attitudini, trascendono oggetti o situazioni specifici. Sono convinzioni più generali che inducono a lottare per raggiungere determinati obiettivi, sono comportamenti o modi di essere che si considerano preferibili a qualsiasi altra alternativa. In questo modo i valori servono come principi e criteri che le persone usano sia consciamente che inconsciamente nei propri giudizi. I valori indicano qualità normative e prescrittive rispetto a ciò che si dovrebbe fare o pensare in differenti situazioni. Per questo motivano certi comportamenti ed attitudini. Per esempio le persone che considerano l’indipendenza un valore importante si ribellano se la loro indipendenza viene minacciata, si disperano quando perdono la speranza di tutelarla e sono felici quando possono goderne.
I valori vanno al di là delle attitudini, trascendono oggetti o situazioni specifici. Sono convinzioni più generali che inducono a lottare per raggiungere determinati obiettivi, sono comportamenti o modi di essere che si considerano preferibili a qualsiasi altra alternativa. In questo modo i valori servono come principi e criteri che le persone usano sia consciamente che inconsciamente nei propri giudizi. I valori indicano qualità normative e prescrittive rispetto a ciò che si dovrebbe fare o pensare in differenti situazioni. Per questo motivano certi comportamenti ed attitudini. Per esempio le persone che considerano l’indipendenza un valore importante si ribellano se la loro indipendenza viene minacciata, si disperano quando perdono la speranza di tutelarla e sono felici quando possono goderne.
La valorizzazione della dignità umana e delle differenze culturali contribuisce alla GC poiché costituisce filtri critici attraverso i quali gli individui leggono l’informazione su altre culture e decidono come impegnarsi con gli altri e con il mondo. Coloro che coltivano questi valori diventano più consapevoli di se stessi e di quelli che li circondano e sono fortemente motivati a lottare contro l’esclusione, l’ignoranza, la violenza, l’oppressione e la guerra.
L’educazione ha una profonda influenza sui valori degli individui. Durante il periodo scolastico i giovani si formano abiti mentali, convinzioni e principi che conserveranno per tutta la vita. Ecco perché è cruciale riflettere sul tipo di educazione che “coltiva l’umanità” al meglio (Nussbaum, 1997). Una educazione che incoraggia a valorizzare la dignità, i diritti umani e la diversità, enfatizza gli elementi che uniscono le persone nel mondo piuttosto che i temi che le dividono; offre esperienze di apprendimento che mettono gli studenti in condizione di vedere il mondo da molte diverse prospettive, rendendoli capaci di esaminare le proprie idee e credenze e le norme e le tradizioni della loro società; incoraggia le persone a capire il significato delle sofferenze altrui ed enfatizza l’importanza di ragionevoli attente argomentazioni, di analisi logiche, di autoanalisi e del perseguimento della verità e della obiettività.
Mentre i più sono d’accordo sul fatto che l’educazione debba aiutare gli studenti a formarsi come esseri umani che hanno a cuore gli altri e li rispettano, decidere quali siano i valori che i sistemi educativi debbano promuovere è ancora oggetto di dibattito. Non è facile identificare un nucleo centrale di diritti che siano universalmente validi ed interpretati nello stesso modo ovunque ed in ogni circostanza, poiché le istituzioni morali e sociali variano a seconda delle culture e dei contesti storici.
L’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo descrive gli elementi costitutivi di un nucleo minimo di diritti che può guidare l’educazione a livello mondiale: “Tutti gli esseri umani sono nati liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e coscienza e dovrebbero agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza”
L’articolo definisce due elementi fondamentali della dignità umana: il primo è che ogni essere umano possiede un valore intrinseco solo per il fatto di essere un essere umano, il secondo è che questo valore dovrebbe essere riconosciuto e rispettato dagli altri e che certe forme di trattamento da parte di altri non sono coerenti con il rispetto per il suo valore intrinseco. Gli individui hanno una precisa obbligazione morale a trattarsi, gli uni con gli altri, con modi caratterizzati da limiti inviolabili. Condividere questo valore spesso significa aiutare gli altri a proteggere ciò che è più importante per loro nella vita.
Il rispetto del diritto fondamentale della dignità umana è spesso associato alla salvaguardia nei confronti delle discriminazioni.
- Clapham (2006) ha suggerito che l’uguaglianza dei diritti fondamentali e della dignità dell’uomo ha quattro aspetti:
- la proibizione di tutti i tipi di trattamenti inumani, dell’ umiliazione o della degradazione delle persone;
- l’assicurazione della possibilità di scelta individuale e delle condizioni per la autorealizzazione e l’autonomia di ciascun individuo;
- il riconoscimento che la protezione della identità di gruppo o di cultura può essere essenziale per la protezione della dignità umana;
- la creazione delle condizioni necessarie per tutti di avere soddisfatti i propri bisogni essenziali.
Martha Naussbaum ha affermato che una società minimamente giusta deve tentare di alimentare e supportare un nucleo centrale di “capacità” di base, definite come capacità di scelta e d’azione (ad esempio essere al sicuro da assalti violenti, essere capaci di immaginare, pensare e ragionare, essere capaci di amare, dolersi, di provare le esperienze di nostalgia, gratitudine o rabbia giustificata, etc). Persone provenienti da tradizioni molto differenti, con concezioni del bene molto diverse possono essere d’accordo di considerare queste “capacità” essenziali come base necessaria per condurre una buona vita.
Un punto controverso riguarda le radici occidentali del concetto di dignità umana e la predominanza occidentale nella discussione e nella definizione dei diritti umani. Tuttavia, profonde riflessioni sulla dignità umana si trovano in parecchi altri Paesi e in culture diverse. Per esempio il concetto di Ubuntu degli indigeni africani ha un rapporto stretto con la concettualizzazione di dignità umana nella filosofia occidentale. Ubuntu generalmente viene tradotto con benevolenza ed umanità ed il suo significato sottolinea il rispetto per la dignità umana e il passaggio dal confronto alla conciliazione (Mogkoro, 1995)
I punti di vista delle diverse culture sulla Competenza Globale
La letteratura, le teorie ed i quadri di riferimento concernenti la GC provengono principalmente dal contesto culturale occidentale euro-americano Tuttavia concetti correlati esistono in molti altri Paesi e culture a livello mondiale. Una interessante prospettiva in questo senso emerge in Sud Africa con il nome di Ubuntu. C’è molta letteratura intorno all’Ubuntu, termine presente nel proverbio zulu “Umuntu Ngumuntu Ngabantu” che significa “ Io sono quello che sono per merito di ciò che siamo tutti». Questo concetto di Ubuntu può essere usato per illustrare una identità collettiva come empatia, connessione, umiltà e compassione. Vi sono altri concetti simili nelle culture indigene della Malesia e delle Ande. Identità collettiva, relazioni e contesto diventano tutti importanti elementi di sottolineatura in altri discorsi culturali sulla GC. Sintetizzando alcuni temi cruciali in differenti culture sui temi della GC, Deardoff ha notato i seguenti elementi chiave: rispetto, ascolto, capacità di adattamento, costruzione di relazioni, visione da molteplici prospettive, autoconsapevolezza ed umiltà culturale.
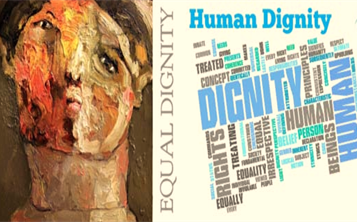
Anche se il contesto culturale varia, il valore centrale del rispetto della dignità umana è sufficientemente robusto da sfidare la legittimazione di un vasto arco di sistemi che abusano del loro potere nei confronti di individui o gruppi. Abusi di potere nei confronti di individui vulnerabili non sono prerogativa di regioni travolte dalla guerra o di stati vulnerabili. Possono succedere ovunque: vicinati, uffici o scuole. Le scuole in particolare sono luoghi in cui la dignità umana assume un significato concreto, poiché ogni studente merita un trattamento giusto, uguali opportunità e dignità.
La discriminazione a scuola si realizza attraverso commenti xenofobi, bullismo, segregazione e scontri fisici. La discriminazione può essere anche meno evidente, ma tuttavia presente in stereotipi, timore degli altri e reazioni inconsce o marginalizzazione di certi gruppi. Insegnare ai giovani ad usare i diritti umani come quadro di riferimento per il loro comportamento può permettere loro di smontare stereotipi, prevenzioni e discriminazioni e di migliorare l’ambiente scolastico e le relazioni sociali nella comunità a cui la scuola appartiene.
Rispettare i diritti umani fondamentali e la dignità è nella maggior parte dei casi compatibile con il rispetto e la valorizzazione della diversità culturale. Gli studenti con GC dovrebbero non solo avere un’attitudine positiva verso le diversità culturali (l’attitudine di apertura e rispetto definita sopra), ma anche valutarla un bene per la società e un obiettivo desiderabile per il futuro. Tuttavia, valutare le diversità culturali ha certi limiti che sono determinati dalla inviolabilità dei diritti umani. La possibile tensione fra i due poli può essere superata stabilendo una gerarchia normativa fra i due: in caso di conflitto, i diritti umani sono più importanti delle diversità culturali.
Promuovere il valore della diversità culturale nelle pratiche educative comporta incoraggiare gli studenti a prendere iniziative per salvaguardare l’eredità culturale tangibile ed intangibile nel mondo; cosi come azioni per promuovere i diritti di tutti di abbracciare le proprie prospettive, visioni, credenze ed opinioni. Ciò significa anche inviare a tutti gli studenti il messaggio che la loro eredità culturale è importante ed arricchisce la società.
Valutare quanto gli studenti si interessano ai valori della dignità umana e della diversità culturale e li apprezzano è complesso e richiede un repertorio ampio di strategie di valutazione, che vanno da interviste o conversazioni, fino alle osservazioni di studenti in situazioni più o meno strutturate. Se valutare tali valori è al di là degli scopi di PISA 2018 sulla GC, si spera che l’inclusione di tali valori in questo framework stimoli un dibattito produttivo su come l’educazione possa sviluppare nei bambini un quadro etico di riferimento per l’assunzione di decisioni fondate sui diritti umani, pur nella diversità di credenze e valori. Riconoscere l’importanza dei valori in educazione non significa promuovere un modo uniforme e fisso di interpretazione del mondo, ma piuttosto implica dare agli studenti alcuni riferimenti essenziali per navigare in un mondo dove non tutti condividono la loro visione, ma ognuno ha il dovere di difendere i principi che permettono a persone differenti di coesistere e di stare bene.
Insegnare attitudini e valori relativi alla GC
Destinare tempo di insegnamento a uno specifico argomento che ha a che fare con problemi relativi ai diritti umani ed alla discriminazione è un passo importante per coltivare i valori della GC. Ma ancor di più si può ottenere applicando il principio del rispetto della dignità umana e della diversità culturale nei confronti degli altri. Per esempio, gli insegnanti possono usare esempi multietnici e multiculturali per illustrare principi e concetti generali o possono ricordare agli studenti i contributi dati da persone appartenenti a gruppi etnici diversi alla loro conoscenza collettiva ed alla qualità della loro vita. Gli insegnanti hanno bisogno di crearsi repertori di esempi di diverse culture, di sviluppare capacità di usarli correntemente ed in modo naturale in classe ed anche di acquisire sicurezza nel farlo.
I valori e le attitudini sono in parte comunicati attraverso il curriculo formale, ma anche attraverso i modi in cui educatori e strumenti interagiscono, come si mantiene la disciplina in classe e come vengono considerati i vari tipi di opinioni e comportamenti. Per esempio una lezione di storia sulla guerra civile USA può enfatizzare il valore della equità razziale, tuttavia, se l’insegnante in classe applica i provvedimenti disciplinari in modo più severo con le minoranze, comunica un sistema di valori contradditorio. E’ evidente che gli studenti assimileranno la cultura della classe più dei contenuti del curriculo. Perciò riconoscere l’influenza dell’ambiente della scuola e della classe sullo sviluppo dei valori degli studenti può aiutare gli educatori a diventare consapevoli degli effetti che il loro insegnamento può avere. Per esempio un insegnante può cambiare la distribuzione dei banchi se vuole incoraggiare l’integrazione razziale o di genere.
Gli insegnanti possono utilmente sostituire gli stereotipi relativi agli studenti delle minoranze o svantaggiati con esempi più positivi. Tuttavia gli insegnanti spesso trovano difficoltà ad impegnarsi in discussioni aperte sulle diversità e sulle discriminazioni; parte del problema è la mancanza di esperienza con persone differenti e la convinzione che le conversazioni sulle discriminazioni ed i problemi di etica generino sempre delle polemiche. Per questo capita che gli insegnanti si concentrino solo sugli argomenti sicuri relativi alla diversità culturale come le somiglianze fra i gruppi, la cucina, i costumi e le feste lasciando da parte gli argomenti più problematici come le ingiustizie, le iniquità e le oppressioni (Gay, 2015).
Queste difficoltà possono essere superate offrendo agli educatori una formazione continua. Specifici programmi e moduli di formazione possono aiutare gli insegnanti ad acquisire: a) una consapevolezza critica del ruolo che le differenti materie ed approcci possono giocare nella battaglia contro il razzismo e la discriminazione, b) le competenze per riconoscere e considerare le diversità dei bisogni degli allievi, in particolare di quelli dei gruppi di minoranza c) ed infine la padronanza di metodi e tecniche di base di osservazione, ascolto e comunicazione interculturale (UNESCO, 2007).
LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA GLOBALE IN PISA

La strategia della valutazione
Valutare la GC in tutta la sua complessità richiede un approccio caratterizzato da diversi metodi e prospettive. La valutazione PISA 2018 della GC contribuisce ad uno sviluppo in questa direzione, sebbene rimangano chiare sfide e limiti. La sfida più importante è quella che un singolo strumento internazionale deve necessariamente tenere conto della grande varietà di contesti culturali e geografici rappresentati nei paesi partecipanti. Gli studenti che hanno buoni risultati in una domanda che valuta la loro capacità di ragionare su un tema globale hanno probabilmente qualche conoscenza pregressa del tema ed il tipo di conoscenza che hanno è influenzata dalla loro esperienza nel proprio contesto sociale. Da una parte la variabilità culturale delle popolazioni testate richiede che il materiale del test non sia troppo inficiato dai pregiudizi di una particolare prospettiva, per esempio la prospettiva dello studente di un Paese ricco che riflette sui problemi di un Paese povero; inoltre i test dovrebbero focalizzarsi su temi rilevanti per 15enni di tutti i Paesi. Dall’altra parte spingersi troppo verso la neutralità culturale nella definizione di scenari e domande riduce l’autenticità e la rilevanza dei compiti. Il profilo del test è ulteriormente limitato dai tempi ristretti della valutazione e dalla scarsa disponibilità di strumenti internazionalmente validi che misurino gli aspetti comportamentali della GC.
Tenendo conto di questi limiti e sfide, PISA 2018 comprende due componenti:
- un test cognitivo esclusivamente focalizzato sul costrutto di “comprensione globale”, definita come la combinazione della conoscenza del background e delle capacità cognitive richieste per risolvere problemi relativi a temi globali ed interculturali;
- un questionario che raduna informazioni che lo studente dà autonomamente sulla sua consapevolezza circa temi e culture globali, sulle sue capacità cognitive e sociali e sulle sue attitudini ed infine informazioni sulle scuole e insegnanti in ordine alle attività sviluppate per promuovere la GC.
Figura 2 L’approccio di PISA alla valutazione della Competenza Globale
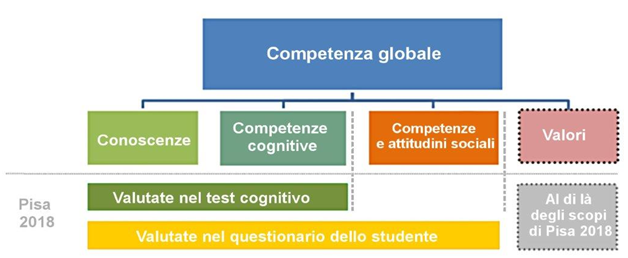
Il rapporto sui risultati rifletterà la differenza fra le due componenti della valutazione. Le risposte degli studenti alle domande di tipo cognitivo possono essere valutate come giuste o sbagliate (o parzialmente giuste o sbagliate) e pertanto possono essere collocate su una scala. Dato che le capacità di comprendere i temi o le situazioni globali o interculturali può essere sviluppata a scuola, la scala di efficacia di PISA deve restituire i risultati in modo che possano essere interpretati in termini di politiche educative.
Per alcune delle domande che misurano tratti attitudinali o socio-emozionali, tuttavia, definire quali sono le risposte giuste e quali quelle sbagliate è più discutibile, poiché lo sviluppo di questi tratti ed il loro contributo alla GC potrebbero non essere lineari (oltre un certo livello, una maggiore “apertura” non è necessariamente meglio).I problemi di misurazione sono anche più acuti negli item in cui gli studenti riferiscono di sè; così graduare gli studenti o i Paesi sulla base delle risposte degli studenti rischia errori di rappresentazione o di interpretazione. Per esempio, chi proviene da alcuni ambienti tende ad esagerare le risposte basate sulla scala Likert (per esempio quelle che richiedono di dichiarare il livello di accordo con alcune affermazioni), mentre in altri contesti si tende ad assestarsi nel mezzo. Le risposte perciò non dovrebbero essere usate per posizionare studenti e Paesi su una scala. Dovrebbero invece essere usate per illustrare i modelli generali e le differenze fra le nazioni nello sviluppo delle capacità e delle attitudini esaminate ed il rapporto fra queste ed il livello di competenza.
La comprensione globale viene valutata nei test cognitivi di PISA chiedendo agli studenti di valutare alcune unità. Ogni unità è composta da uno scenario (o studio di caso) e da vari compiti basati su di esso. Lo studente legge un caso e risponde a domande (altrimenti chiamate test item) che valutano la sua capacità di capire la sua complessità e le prospettive dei diversi attori coinvolti. Ogni scenario espone lo studente ad una gamma di situazioni differenti e mette alla prova le sue capacità di applicare le sue conoscenze di background ed le sue capacità cognitive di analizzare la situazione e suggerire le soluzioni.
Le capacità cognitive richieste dalla comprensione globale sono misure importanti di tutte le quattro dimensioni della GC della studente
- La dimensione 1 “esaminare temi globali ed interculturali” può essere valutata attraverso test che chiedono agli studenti di analizzare criticamente affermazioni ed informazioni.
- La dimensione 2 “comprendere i punti di vista” può essere valutata attraverso test che esaminino la capacità dello studente di: a) riconoscere differenti punti di vista, avendo consapevolezza delle proprie “lenti” e dei propri pregiudizi come di quelli degli altri, b) considerare il contesto (culturale, religioso, regionale) che le influenza e trovare un possibile “terreno comune” fra le diverse prospettive.
- La dimensione 3 “impegnarsi in interazioni efficaci ed appropriate” può essere valutata attraverso prove che testino le capacità degli studenti di capire il contesto comunicativo e le regole di un dialogo rispettoso.
- Infine la dimensione 4 ” agire per la sostenibilità ed il benessere” può essere valutata attraverso la capacità dello studente di considerare le possibili azioni per combattere i problemi globali e di valutare le conseguenze dirette ed indirette di tali azioni.
Il Questionario Studente offrirà informazioni aggiuntive circa le attitudini, conoscenze e capacità necessarie per destreggiarsi nella vita di ogni giorno in maniera competente a livello globale e culturale, ma queste misure vanno al di là dei parametri dei test cognitivi di PISA. Le capacità e le attitudini riportate autonomamente dagli studenti saranno misurate attraverso scale del tipo Likert che sono state selezionate sulla base di una rassegna di specifici studi empirici.
Figura 3 Elementi di una tipica unità di test sulla Competenza Globale in PISA 2018
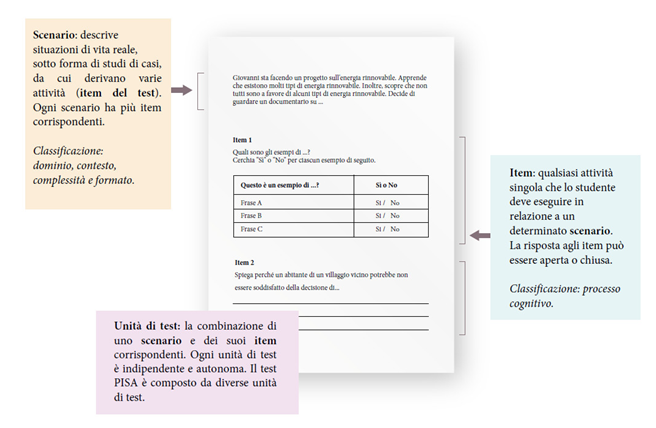
Il test cognitivo sulla comprensione globale

Una breve rassegna di valutazioni cognitive in questa area
La ricerca in questa area è stata basata principalmente su rapporti redatti direttamente dagli studenti ed esistono pochi esempi di valutazioni cognitive. Nella Rassegna sulla Comprensione Gobale (Global Understanding Survey) (GUS) gli autori hanno definito la Comprensione Globale come una somma di 4 componenti:
1) sapere, 2) attitudini e percezioni, 3) correlazioni generali di background, 4) efficacia espressiva.
 L’ambito della conoscenza nella GUS consisteva in 101 domande a scelta multipla concernenti istituzioni internazionali, grandi avvenimenti e tendenze storiche, quadri di riferimento legali e di policy associati con 13 temi globali.
L’ambito della conoscenza nella GUS consisteva in 101 domande a scelta multipla concernenti istituzioni internazionali, grandi avvenimenti e tendenze storiche, quadri di riferimento legali e di policy associati con 13 temi globali.
Gli item nella GUS erano indirizzati a temi globali. Gli studenti che riferivano di fare un regolare utilizzo delle informazioni ottenevano punteggi alti. Tuttavia i ricercatori hanno trovato solo deboli correlazioni fra le esperienze educative degli studenti – corsi, studio delle lingue o studio all’estero- e il loro livello di conoscenze internazionali. Il rapporto finale riconosceva anche che la valutazione aveva fornito solo un’osservazione limitata della natura e dello sviluppo della comprensione globale.
Gli Studi IEA sull’Educazione alla cittadinanza e lo Studio Internazionale sul Civismo e la Cittadinanza (International Civic and Citizenship Study) (ICCS), sono altri esempi che possono orientare lo sviluppo degli item in PISA. Le domande chiave in ICCS riguardano i risultati degli studenti nella educazione civica e di cittadinanza e la loro disposizione ad impegnarsi su tali temi. ICCS misura i processi cognitivi di conoscenza, ragionamento ed analisi attraverso quattro aree di contenuto che comprendono: 1) la società ed i sistemi civici, 2) i principi civici, 3) la partecipazione civica, 4) le identità civiche. Il format mette insieme domande chiuse a risposta multipla e domande a risposta aperta.
Alcuni degli items di ICCS misurano la capacità di analisi e ragionamento. Ragionare richiede agli studenti di applicare la conoscenza e la comprensione di concrete situazioni famigliari per giungere a conclusioni su situazioni complesse dai molti aspetti non famigliari ed astratte.
Fuori dal contesto della educazione globale e civica un crescente numero di valutazioni ha tentato di misurare la capacità dello studente di valutare informazioni e di pensare criticamente ai problemi. In molti casi lo studente legge un breve testo e decide se una serie di affermazioni relative ad esso sono vere o false. Alcune includono domande in cui gli studenti debbono sviluppare argomentazioni logiche o spiegare come le risposte di qualcun altro possano essere verificate o rafforzate. Tutte queste valutazioni pongono fortemente l’accento su ragionamento, analisi, argomentazione e valutazione. Questi test tuttavia trattano queste capacità su di un piano generale, mentre PISA guarda alla loro applicazione sul terreno dei problemi globali ed interculturali.
La Valutazione della Lettura Basata su uno Scenario Globale Integrato (Global Integrated Scenario Based Assessment of Reading) (GISA) è un altro importante punto di riferimento. GISA valuta l’”abilità di literacy globale”, una competenza multidimensionale che richiede agli studenti non solo di usare i testi, ma anche di impiegare altre abilità cognitive di linguaggio e di ragionamento sociale, così come di fare ricorso alle proprie conoscenze, strategie e disposizioni. Diversamente dalle tradizionali valutazioni sulla Lettura che presentano agli studenti un insieme di test non collegati fra di loro e non offrono nessuno scopo per leggerli, GISA usa un approccio basato su uno scenario con una sequenza di compiti accuratamente strutturata. Impiegando scenari che offrono contesti autentici e dando obiettivi di lettura, la valutazione riflette meglio i processi cognitivi che gli studenti utilizzano, quando si trovano a confrontarsi con attività di apprendimento reali. GISA prevede anche attività di collaborazione. Per esempio, chi si sottopone ai test interagisce con dei pari simulati per identificare errori, correggere concezioni errate ed offrire feedback. Chi partecipa alle interazioni simulate può dichiarare fatti, presentare informazioni non corrette, dare le proprie opinioni e andare fuori argomento, proprio come la gente fa nella vita reale. Conoscenze di sfondo, strategie di autoregolazione e motivazione son anche misurate in GISA e sono usate per definire il punteggio relativo alla Lettura.
Esistono relativamente poche valutazioni sulla capacità di assumere prospettive. Un esempio rilevante per PISA è la Catalyzing Comprehension through Discussion and Debate (CCDD). Questo tipo di valutazione è finalizzata a valutare l’abilità di riconoscere, articolare, collocare ed interpretare le diverse posizioni in un conflitto sociale e prevedere soluzioni che tengano in considerazione ed integrino le rispettive differenti prospettive o punti di vista. Gli studenti sono posti nei panni di un “consigliere” che si possa occupare dei conflitti che possono verificarsi in differenti contesti. In una unità viene letta una storia su uno studente di nome Casey, vittima di bullismo e si chiede che cosa si consiglierebbe di fare e perché. Si chiede inoltre di identificare le potenziali conseguenze negative di tali raccomandazioni. Le risposte a queste domande debbono essere corte ed aperte.
Definire il costrutto di comprensione globale
 L’accesso alla informazione globale e le opportunità di incontro interculturale sono molto cresciute nell’ultima decade, il che significa che la maggioranza degli studenti PISA sono esposti ad un arco ampio di prospettive su temi globali e di esperienze interculturali, anche se non le ricercano.
L’accesso alla informazione globale e le opportunità di incontro interculturale sono molto cresciute nell’ultima decade, il che significa che la maggioranza degli studenti PISA sono esposti ad un arco ampio di prospettive su temi globali e di esperienze interculturali, anche se non le ricercano.
Tuttavia l’accesso all’informazione sul mondo e le altre culture non va sempre insieme con la loro comprensione. La ipersemplificazione di conoscenze complesse dà un contributo significativo alle carenze nell’apprendimento ed è particolarmente frequente nel campo delle tematiche globali e culturali. Per quanto concezioni errate spesso nascano da una mancanza di informazioni, esse sono anche rinforzate dal fatto che cr edenze iniziali forti su come funziona il mondo sono difficili da modificare. Posto che gli esseri umani imparano creando sistemi di classificazione, una mancanza di nuove conoscenze o di esperienza può condurre a categorizzazioni e generalizzazioni ipersemplificate che a loro volta sfociano in pregiudizi e stereotipi. Tuttavia concezioni errate sorgono anche quando gli studenti sono esposti ad informazioni adeguate, ma le assorbono in modo passivo senza riflettere sul loro più profondo significato o usando le informazioni per adattare le loro precedenti credenze.
Gli studenti hanno bisogno di usare la conoscenza e le abilità simultaneamente per sviluppare la comprensione globale. Se uno studente non sa molto su un certo tema, trova difficile identificare difetti in un testo, considerare multiple prospettive, comunicare in modo ricco e considerare le conseguenze delle azioni relative al tema in questione. Tuttavia, la conoscenza da sola senza comprensione ha poco valore. Si può sapere e continuare a giudicare superficialmente. Capire è la capacità di usare la conoscenza per trovare significati e connessioni fra differenti informazioni e prospettive.
Il processo cognitivo che supporta la comprensione globale
 Per fini analitici e sintetici questo Framework distingue quattro processi cognitivi legati fra loro, che gli studenti competenti hanno bisogno di usare per comprendere a fondo le situazioni ed i problemi interculturali:
Per fini analitici e sintetici questo Framework distingue quattro processi cognitivi legati fra loro, che gli studenti competenti hanno bisogno di usare per comprendere a fondo le situazioni ed i problemi interculturali:
- la capacità di valutare informazioni, formulare argomentazioni e spiegare situazioni complesse e problemi usando e collegando i fatti, identificando i vuoti ed i travisamenti nell’informazione e gestendo argomentazioni in conflitto fra loro;
- la capacità di identificare ed analizzare molteplici prospettive e visioni del mondo, posizionando e connettendo le prospettive proprie e degli altri;
- la capacità di capire le differenze nella comunicazione, riconoscendo la importanza di convenzioni comunicative socialmente appropriate ed adattando la comunicazione alle richieste dei diversi contesti culturali;
- la capacità di valutare le azioni e le loro conseguenze, identificando e paragonando differenti serie di azioni e valutando queste azioni l’una a confronto dell’altra sulla base delle conseguenze di corto e lungo termine.
Gli studenti con GC dovrebbero così essere capaci di realizzare un’ampia varietà di compiti, usando diversi processi cognitivi. Il primo di questi richiede di essere capaci di ragionare sulla base di fatti su un tema o situazione locale, globale ed interculturale, di ricercare in modo efficace utili fonti di informazione, di valutare le informazioni sulla base della loro rilevanza ed affidabilità, di sintetizzare le informazioni per descrivere le idee principali in un testo argomentativo o i passaggi salienti di una conversazione ed infine combinare la loro conoscenza di sfondo, nuove informazioni e ragionamento critico per costruire spiegazioni a più facce su temi globali e multiculturali.
Non solo, la solida comprensione di un problema globale o interculturale richiede di riconoscere che le credenze ed i giudizi di ciascuno sono sempre contingenti e dipendenti dalle sue affiliazioni e prospettive. Gli studenti dovrebbero perciò essere capaci di riconoscere i punti di vista di altre persone o di gruppi ed i fattori che potrebbero influenzarli, incluso l’accesso ad informazioni e risorse. Gli studenti debbono saper spiegare come le prospettive ed i contesti modellano le interazioni umane e le interpretazioni di eventi, problemi o fenomeni.
Gli studenti con GC dovrebbero anche saper individuare modi per gestire i conflitti che emergono dai problemi di comunicazione, analizzando i contesti comunicativi e le convenzioni e riconoscendo i segnali di riferimento.
Infine gli studenti dimostrano il loro livello di comprensione globale quando sono capaci di valutare diversi tipi di azione, proporre soluzioni e considerare le implicazioni immediate ed indirette di tali azioni. L’ultimo processo cognitivo costitutivo della comprensione globale perciò coinvolge l’abilità di trarre conclusioni significative dalle informazioni che si possiedono e che si acquisiscono.
Differenti tipi di compiti provano i livelli di efficacia nell’applicare ciascuno di questi processi cognitivi correlati ad un problema globale o interculturale. Per esempio, agli studenti si può richiedere di scegliere la fonte di informazione più attendibile su di un tema fra differenti fonti di informazione, di valutare se una affermazione è valida e basata su prove, di sintetizzare e spiegare un problema o una situazione o di scegliere fra possibili sintesi. E ancora, si può ancora richiedere di individuare i passaggi di un messaggio mediatico che trasmette stereotipi negativi o frettolose generalizzazioni, di identificare i differenti portatori di interesse in un caso e di enumerare le possibili ragioni relative alla loro cultura o al contesto che stanno dietro le rispettive posizioni. Possono infine individuare quali passaggi, in una conversazione, dimostrano una chiara ignoranza degli approcci di comunicazione interculturale, o si può chiedere loro di enumerare o selezionare le conseguenze possibili di una soluzione proposta per un problema.
Figura 4 La relazione fra il test cognitivo di GC e le dimensioni di GC

Mentre tutti e quattro i processi cognitivi sono importanti indicatori delle capacità dei soggetti globalmente competenti, ai test di PISA 2018 di GC non si chiede di coprire tutti e quattro i processi cognitivi allo stesso modo. In particolare è notevolmente complesso creare test che misurino, in modo valido, la comprensione degli studenti di norme di comunicazione e delle diversità (processo 3) e potrebbe richiedere un periodo più lungo di sviluppo e validazione. Questo processo cognitivo sarà perciò meno rappresentato degli altri tre nel test PISA 2018.
La tabella 1 descrive ai tre livelli, di base, intermedio ed avanzato, le abilità degli studenti di sviluppare le quattro tipologie dei processi cognitivi che costituiscono la comprensione globale, l’aspetto cognitivo della GC.
Tabella 1 Tipologie di processi cognitivi per livello nel test PISA 2018 di GC
| PROCESSO COGNITIVO |
SOTTOCATEGORIA | DI BASE |
INTERMEDIO | AVANZATO |
| Valutare informazioni, formulare argomentazioni e spiegare situazioni o problemi complessi. | Selezionare le fonti (graduatoria) | Lo studente preferisce usare fonti provenienti dal suo contesto culturale, senza avere una apparente strategia di ricerca, di selezione o di differenziazione fra le fonti. | Lo studente ricerca e seleziona fonti provenienti da contesti geografici o culturali al di là dei propri. Può anche cercare e selezionare più di un tipo di fonte (giornali, pubblicazioni, rapporti governativi, testimonianze personali). Tuttavia non appare alcuna strategia concreta, al di là di quella di usare fonti differenti | Lo studente è in grado di collocare la ricerca sistematicamente in un quadro che permette di identificare la natura e la ampiezza della informazione necessaria. Seleziona le fonti consapevolmente, definendo i contesti e le tipologie che informeranno la comprensione del tema esaminato. |
| Valutare le fonti (affidabilità e rilevanza) | Lo studente assume le informazioni secondo il loro valore apparente, senza considerare i fattori di contesto (autore, geoprospettive, cultura) o il tipo di fonte. Non è ancora in grado di individuarne inattendibilità o inconsistenza né di valutare l’importanza delle fonti in relazione al tema esaminato. | Lo studente valuta le fonti in relazione alla loro rilevanza per il tema esaminato, considera i fattori di contesto che possono incidere sulla loro attendibilità, può individuare gli elementi di attendibilità o di errore, anche se solo in chiave binaria (sì-no). | Lo studente presta attenzione ai fattori di contesto per definire la attendibilità e rilevanza delle fonti, comprende il significato delle loro diverse prospettive. può distinguere le intenzioni comunicative (fatti, opinioni, propaganda), valutare se le premesse sono fondate o ragionevoli ed identificare quelle che sottendono stereotipi. | |
| Usare le fonti (ragionare con i fatti) | Lo studente vede l’uso delle fonti come un semplice, non problematica questione di copiatura e reimpasto delle informazioni. | Lo studente capisce la necessità dell’uso di più fonti, ma usa un approccio meccanico nel loro utilizzo(ad esempio due a favore e due contro). | Lo studente riconosce la natura provvisoria delle prove e che da fonti simili possono derivare argomentazioni diverse. Può prendere in considerazione fatti da analizzare e confrontarsi argomentazioni opposte. Può anche confrontarsi con tesi o fonti in conflitto. | |
| Descrivere e spiegare situazioni e problemi complessi | Lo studente può produrre brevi sintesi di informazioni o prospettive che consistano in una serie di informazioni con poca organizzazione significativa. Non è ancora capace di classificare le informazioni. | Lo studente può descrivere il tema/situazione in causa connettendola a concetti più ampi (cultura, identità, migrazione) facendo semplici esempi.Può ordinare i contenuti in modo da facilitare la comprensione degli altri. | Lo studente può descrivere il tema/situazione in causa connettendola a concetti più ampi (cultura, identità, migrazione) con esempi significativi. Può sviluppare ed esprimere chiare, robuste ed efficaci argomentazioni che sintetizzano e mettono in connessione le informazioni offerte dal compito e quelle che ha acquisito dentro o fuori la scuola. | |
| PROCESSO COGNITIVO | SOTTOCATEGORIA | DI BASE | INTERMEDIO | AVANZATO |
| Identificare ed analizzare prospettive e visioni del mondo multiple | Riconoscere le prospettive e le visioni del mondo | Lo studente ha una visione semplicistica delle prospettive: una persona, una prospettiva. Non ne può ancora spiegare la fonte, vede il contesto come irrilevante o deterministico.Vede le prospettive culturali, religiose e linguistiche come relativamente fisse, blindate, segnali impermeabili di visioni del mondo o di identità personale (prevalentemente di una categoria, nazionalità o religione). Non pensa di avere una propria distinta personalità culturale e pensa che ciò che sa sia la norma. | Lo studente può identificare su di un tema differenti attori e punti di vista. Comincia a riconoscere che le differenze hanno le loro radici nel background culturale, religioso e socioeconomico del contesto e che lui stesso è portatore di una particolare visione. Non può ancora articolare le relazioni fra queste diverse visioni. | Lo studente può descrivere ed interpretare multiple prospettive e ne capisce i diversi background. Capisce anche che una individualità è complessa (uno può essere insieme una ragazza, una figlia, un agricoltore ed un cittadino). Può articolare le relazioni fra le diverse prospettive, ponendole in una cornice più ampia e comprensiva (quando vede che due compagni di diversi gruppi etnici si combattono a causa di pregiudizi capisce che le loro relazioni riflettono più ampie tensioni nella società di oggi). Vede le sue prospettive e zone di ombra, capisce che sono determinate dal suo contesto culturale e dalle sue esperienze e che gli altri la possono vedere in modo diverso. |
| Identificare le connessioni | Lo studente non riconosce le connessioni fra gli esseri umani, a parte gli aspetti fisici e gli indicatori culturali evidenti. Non riconosce l’impatto che le azioni hanno sugli altri e vede gli individui di differenti culture o contesti così distanti o esotici da pensare e comportarsi differentemente e da non condividere simili bisogni o diritti. | Lo studente riconosce che persone provenienti da diversi contesti condividono diritti umani e bisogni (cibo, rifugio, lavoro, educazione, felicità). Conosce il significato di questi diritti e bisogni ed alcuni dei modi in cui possono essere soddisfatti | Lo studente apprezza i diritti ed i bisogni umani comuni e riflette criticamente sulle differenze individuali, culturali e di contesto comprendendo gli ostacoli che gli individui e le società possono incontrare (diseguaglianza economica, relazioni di potere diseguali,violenza e condotte insostenibili) nell’affermare i loro diritti alla diversità ed al benessere.Capisce anche che i diritti umani lasciano considerevole spazio alle individualità nazionali, regionali e culturali e ad altre forme di diversità e che essi permettono agli individui ed ai gruppi di perseguire la loro visione di ciò che costituisce una buona vita, fintanto che le loro scelte non sono di ostacolo ai diritti umani fondamentali degli altri. | |
| PROCESSO COGNITIVO | SOTTOCATEGORIA | DI BASE | INTERMEDIO | AVANZATO |
| Capire le differenze nella comunicazione | Capire il contesto comunicativo ed il dialogo rispettoso | Lo studente non sa ancora come comunicare in modo appropriato ed efficace in relazione all’uditorio ed al contesto.In modo specifico, non ne riconosce le norme culturali, gli stili di interazione, le aspettative o i livelli di formalità. Non è ancora capace di osservare, ascoltare attentamente ed interpretare elementi chiave come linguaggio del corpo, tono, dizione, interazioni fisiche, regole di abbigliamento e silenzi. E’ sorpreso da ogni interruzione nella comunicazione e manca di un repertorio comunicativo che risolva le situazioni. |
Lo studente è consapevole del suo modo di comunicare e cerca di adattarlo al contesto. Può identificare le caratteristiche del contesto, ma non sa ancora adattarvi le sue scelte. Sa affrontare le crisi nella comunicazione chiedendo ripetizioni o riformulazioni, ma lo fa solo per tentativi. | Lo studente conosce il proprio stile e capisce che deve essere adattato ai contesti, di cui coglie le sfumature. E’ capace di osservare, ascoltare attentamente ed interpretare elementi chiave e sa gestire le crisi. Impiega strumenti linguistici come evitare affermazioni categoriche, riferirsi a quanto detto da altri, condividere domande e quesiti e riconoscendo i contributi degli altri, in modo da avanzare nel dialogo civile reciproco. |
| PROCESSO COGNITIVO | SOTTOCATEGORIA | DI BASE | INTERMEDIO | AVANZATO |
| Valutare le azioni e le loro conseguenze | Considerare le azioni | Lo studente considera un solo tipo di azione come ovvio e privo di problemi. Ad esempio, nel caso di inquinamento la soluzione è “chiudere tutte le fabbriche inquinanti”. | Lo studente capisce che sono possibili molti tipi di azioni sono possibili e necessari per affrontare un problema o contribuire al benessere di individui e società in un dato campo. Può individuare direzioni future in cui indagare, se ciò che è a disposizione non è sufficiente per individuare il miglior tipo di azione. | Lo studente dimostra la capacità di identificare e valutare diversi tipi di azione. Le valuta l’una a confronto con l’altra, guardando ai precedenti, considerando e valutando quanto c’è a disposizione e pensando alle condizioni che possono rendere possibile l’azione. |
| Valutare le conseguenze ed implicazioni | Lo studente capisce le implicazioni di azioni semplici in termini lineari, senza valutare azioni ed implicazioni multiple e senza considerare conseguenze non volute. | Lo studente capisce le più immediate ed evidenti conseguenze di un tipo di azione e come queste conseguenze possono essere paragonate con quelle di altri tipi di azione. | Lo studente considera le conseguenze immediate e quelle indirette di differenti possibili azioni e decisioni. Può valutarne le conseguenze vicine e lontane nel tempo e nello spazio. Considera anche la possibilità di conseguenze non volute. |
Contenuto delle unità di test
Una tipica unità di test è basata su uno scenario centrato su un tema globale o interculturale e presenta diverse prospettive.
Gli scenari sono spesso usati come strumenti di insegnamento ed il loro uso può offrire utili prove per le politiche educative e per gli insegnanti, poiché incoraggiano gli studenti a pensare in modo logico e sistematico.
Un quadro basato su scenari in una valutazione internazionale presuppone che sia possibile identificare un insieme di grandi problemi che tutti i giovani abbiano appreso, indipendentemente da dove vivono o dal loro background socioculturale. Tuttavia è difficile tracciare una delimitazione esatta dei contenuti rilevanti per gli scenari, poiché i temi globali ed interculturali sono in costante evoluzione.
Ad ogni modo la tabella 2 delinea quattro ambiti di contenuto ed i loro relativi sottodomini, considerati rilevanti per tutti gli studenti. Ogni scenario nel test cognitivo PISA può perciò essere categorizzato in uno di questi sottodomini di contenuto.
Tabella 2 Ambiti di contenuto e sottoambiti degli scenari
| AMBITO DI CONTENUTO | SOTTOAMBITO |
| Cultura ed interrelazioni culturali | Formazione delle identità nelle società multicultuali |
| Espressione culturale e scambi culturali | |
| Comunicazione interculturale | |
| Stereotipi, discriminazione ed intolleranza | |
| Sviluppo socioeconomico ed interdipendenza | Interazioni economiche ed interdipendenza |
| Capitale umano sviluppo ed inequità | |
| Sostenibilità ambientale | Risorse naturali e rischi ambientali |
| Politiche pratiche e comportamenti per la sostenibilità ambientale | |
| Istituzioni, conflitti e diritti umani | Prevenzione di conflitti e crimini dell’odio |
| Diritti umani universali e tradizioni locali | |
| Partecipazione politica ed impegno globale |
I produttori di test dovrebbero mirare ad una copertura equilibrata di queste aree attraverso le diverse unità che costituiscono ciascun test cognitivo di 1 ora, favorendo scenari trasversali a diverse aree. Dovrebbero privilegiare stimoli familiari e significativi per i quindicenni, per facilitarne l’impegno. I rischi associati con temi sensibili (per esempio, casi di studio relativi a violenza causata dall’ odio verso le minoranza possono essere sensibili per studenti che provengano da questi ambienti) dovrebbero essere attentamente valutati e ridotti al minimo, nella definizione dello scenario e dei test relativi. La combinazione di strumenti di comunicazione adeguati come testi, fumetti e fotografie può innalzare la qualità e l’interesse dello scenario, riducendo il peso della lettura ed aumentando l’impegno degli studenti. E’ anche importante evitare scenari che presentino una rappresentazione stereotipata di certe identità o gruppi culturali, che potrebbero contribuire a rinforzare o creare pregiudizi.
Gli scenari possono variare per contenuto ed anche per contesto. Per esempio, possono riferirsi a contesti personali (il sé, la famiglia ed il gruppo dei pari), al contesto locale (reti sociali più ampie come vicinato, città o nazione) o ad un contesto globale (la vita nel mondo come sperimentato attraverso i media e la partecipazione a reti sociali).Per esempio, nel contesto personale della interazione dello studente in una classe multiculturale-per cui una classe multiculturale racchiude differenze non solo di nazionalità, ma anche di genere, religione e livello socioeconomico- gli studenti possono essere valutati sulle loro comunicazioni interculturali e sulle capacità di comprensione (processi cognitivi 2 e 3 e area 1 di contenuto). Gli scenari che comprendono storie di conflitti o di scambi culturali positivi in un vicinato multiculturale (contesto locale) possono servire come utile sfondo per test che valutino la comprensione degli studenti delle sfide della integrazione sociale all’interno della loro comunità locale. Gli scenari nei quali agli studenti si richieda di analizzare notizie globali o di lavorare da remoto ad un progetto con studenti di un Paese differente possono attingere ad una ampia gamma di domini di contenuto e di processi cognitivi.
Complessità delle unità di test.
 L’uso efficace dei processi cognitivi valutati (tabella 1) è intimamente legato alla conoscenza dei contenuti da parte degli studenti del tema o situazione sulla quale si richiede loro di lavorare. Mentre le capacità cognitive relative all’analisi ed alla valutazione delle informazioni sono intrinsecamente generali, i temi globali ed interculturali presentano specifiche sfide che richiedono conoscenza del mondo e delle differenze culturali. Per esempio, solo quegli studenti che hanno un certo grado di conoscenza della conseguenze dei cambi climatici possono pienamente comprendere le posizioni contrastanti in un dibattito sulla riduzione delle emissioni di carbonio nelle città. Del pari, se uno studente non sa niente su di un tema, farà fatica a considerarlo da prospettive multiple. La conoscenza del contenuto del background è in questo quadro un facilitatore importante dei processi cognitivi che gli studenti usano quando si chiede loro di riflettere su un particolare studio di caso presentato in una unità.
L’uso efficace dei processi cognitivi valutati (tabella 1) è intimamente legato alla conoscenza dei contenuti da parte degli studenti del tema o situazione sulla quale si richiede loro di lavorare. Mentre le capacità cognitive relative all’analisi ed alla valutazione delle informazioni sono intrinsecamente generali, i temi globali ed interculturali presentano specifiche sfide che richiedono conoscenza del mondo e delle differenze culturali. Per esempio, solo quegli studenti che hanno un certo grado di conoscenza della conseguenze dei cambi climatici possono pienamente comprendere le posizioni contrastanti in un dibattito sulla riduzione delle emissioni di carbonio nelle città. Del pari, se uno studente non sa niente su di un tema, farà fatica a considerarlo da prospettive multiple. La conoscenza del contenuto del background è in questo quadro un facilitatore importante dei processi cognitivi che gli studenti usano quando si chiede loro di riflettere su un particolare studio di caso presentato in una unità.
Quando gli studenti leggono un testo o seguono una conversazione presentata nello scenario di ogni unità di test, la loro comprensione è perimetrata sia dal contenuto e complessità del materiale dello scenario sia dallo sviluppo dei processi cognitivi necessari per la GC. La richiesta cognitiva delle unità di test è perciò definita dal livello di conoscenza del contenuto e delle capacità cognitive necessarie agli studenti per risolvere i compiti proposti. In unità di test più impegnative lo studente deve contribuire con informazioni tratte dalle sue conoscenze sull’area di contenuto proposta, non esplicitate nello scenario.
La Tabella 3 definisce il livello di complessità delle unità di test a seconda del livello delle conoscenza del contenuto e delle capacità generali di lettura richieste dallo scenario e dai diversi test. Per quanto la capacità di decodificazione del linguaggio e le abilità di comprensione non siano componenti proprie della GC, il linguaggio usato nello scenario dei test e negli item ne influenzerà inevitabilmente la difficoltà. Bisogna perciò evitare un linguaggio altamente complesso, per ridurre il rischio che i risultati dei test siano pesantemente influenzati dalle differenze nella decodificazione dei test e nella capacità di comprensione del linguaggio. Quanto alla conoscenza di specifici contenuti, l’avere avuto in precedenza informazioni rilevanti o condivisione di situazioni interculturali costituisce un elemento importante per la difficoltà dei test e quindi per la performance dello studente.
Tabella 3 Dimensioni e livelli di complessità degli scenari
| LIVELLO DI COMPLESSITA’ |
CONOSCENZA DI UN CONTENUTO SPECIFICO |
PERCENTUALE DI SCENARI |
CONOSCENZA GENERALE (TEST E LINGUAGGIO) |
PERCENTUALE DI SCENARI |
| Basso | L’argomento analizzato è famigliare a una vasta maggioranza di studenti. Per capire ciò che viene richiesto è necessaria una conoscenza preventiva molto limitata. | Circa il 40% | Lo scenario utilizza un linguaggio molto semplice, senza parole tecniche o espressioni che sono tipiche di un certo gruppo socioculturale o demografico. | Circa il 60% |
| Medio | La maggior parte degli studenti ha famigliarità con questo argomento ma non necessariamente con tutti i suoi aspetti. | Circa il 40% | Il linguaggio dello scenario è famigliare per la maggioranza degli studenti poiché la scelta delle parole è tipica di comunicazioni indirizzate ad ascoltatori non specialisti.Le differenze fra i gruppi nello stile comunicativo sono minime, quando si usano come scenari delle conversazioni.I singoli test sono coerenti internamente ed i diversi test sono fra loro collegati. | Circa il 30% |
| Alto | La maggior parte degli studenti ha sentito parlare dell’argomento, ma, vista la sua complessità, non vi è famigliare Quelli che ne sanno di più possono impegnarsi meglio e ci si aspetta che facciano significativamente meglio. | Circa il 20% | Lo scenario e’ caratterizzato da un linguaggio più complesso che è tipica di una scrittura formale o di conversazioni professionali e può includere una piccola quantità di termini tecnici Le comunicazioni fra gli attori possono riflettere le differenze di stile comunicativo fra i gruppi, anche se la maggior parte degli studenti può seguire la conversazione e capire il suo significato generale, poiché non vengono usati gergo o frasi involute. | Circa il 19% |
Le asimmetrie internazionali nelle possibilità di conoscenza dell’argomento del test sono probabilmente più importanti in una valutazione di GC che in una relativa alle materie tradizionali. Questo perché solo una minoranza di scuole include oggi tale formazione in modo esplicito nel curriculo ed il contenuto della educazione globale varia molto fra i diversi Paesi. In più, il processo di apprendimento della GC ha luogo in un contesto che va molto al di là della classe: un importante fattore che determina la misura in cui gli studenti vengono a conoscenza di temi globali e relativi ad altre culture può essere attribuito al differenziato contesto socioculturale in cui vivono ed imparano. Apprendere la GC è una attività culturale, non solo perché è in parte acquisita attraverso interazioni sociali ma anche perché il processo è influenzato dal modo in cui specifici gruppi culturali interpretano il mondo e trasmettono le informazioni.
Queste asimmetrie nella conoscenza hanno un peso nei risultati dei test. Tuttavia la struttura dei test rende la valutazione di PISA diversa da un quiz di conoscenza. In primo luogo nessun test valuta direttamente conoscenze di fatti specifici (per esempio nessun test chiederebbe di specificare la crescita nella temperatura globale registrata nell’ultimo Panel Internazionale sui Cambiamenti Climatici). In secondo luogo, solo una minoranza di test richiede agli studenti di avere un alto livello di conoscenza sui temi globali ed interculturali.
Mentre la conoscenza dei contenuti aiuta la comprensione dello scenario da parte degli studenti, la performance nel test dovrebbe principalmente riflettere le capacità dello studente di usare il proprio ragionamento e le proprie capacità di capire le prospettive, per correlare la conoscenza generale dei temi a problemi e situazioni inediti. La struttura del test mitiga le asimmetrie poiché chiede di lavorare su alcuni brevi test in domini differenti di contenuto. Gli studenti sottoposti al test provenienti da un certo contesto avranno più conoscenza alle spalle in alcune aree piuttosto che in altre.
Format degli scenari
 Gli scenari usati nei test dovrebbero riflettere la varietà di contesti e ruoli nei quali gli studenti possono apprendere su questioni globali o esplorare la complessità delle interazioni interculturali. La autenticità e rilevanza dei compiti sono criticamente importanti per stimolare un livello sufficiente di impegno nel test. Gli scenari possono essere definiti utilizzando i seguenti 4 scenari che assegnano un ruolo particolare allo studente, offrendo una chiara finalità al suo impegno.
Gli scenari usati nei test dovrebbero riflettere la varietà di contesti e ruoli nei quali gli studenti possono apprendere su questioni globali o esplorare la complessità delle interazioni interculturali. La autenticità e rilevanza dei compiti sono criticamente importanti per stimolare un livello sufficiente di impegno nel test. Gli scenari possono essere definiti utilizzando i seguenti 4 scenari che assegnano un ruolo particolare allo studente, offrendo una chiara finalità al suo impegno.
- Studenti come ricercatori. Agli studenti si richiede di immaginare di essere iscritti ad un corso a scuola e di dover presentare al termine del quadrimestre una ricerca in collaborazione con gli altri studenti. In questo scenario lo studente deve esaminare le informazioni provenienti da ricerche sul web o da stimoli degli altri studenti del team. Questo format testa diversi tipi di processi cognitivi: le capacità degli studenti di selezionare informazioni possono essere valutate presentando loro diversi risultati dalle ricerche web e chiedendo loro di selezionare la più appropriata per la ricerca, mentre quella di assumere prospettive può essere valutata chiedendo loro di esaminare le cause di incomprensioni e conflitti tra due membri del team.
- Studenti come reporter. Lo scenario chiede agli studenti di mettersi nei panni di un giornalista che vuole scrivere un articolo su una notizia che ha sentito. In questo tipo di scenario, il test prende la forma di un estratto da un giornale o dai social media dove sono presentati i principali elementi di un caso. Una prima questione o insieme di questioni verifica se lo studente capisce il messaggio, può valutare la qualità e la credibilità della informazione riportata nella fonte e può ragionare al di là del testo, interrogando le possibili motivazioni e le soggettive interpretazioni della informazione da parte dell’autore. Si chiede poi agli studenti di ricercare le loro informazioni e fonti, per esempio chiedendo loro di identificare quali stakeholder vorrebbero intervistare, o di selezionare domande rilevanti da porre loro per capire meglio le loro azioni e prospettive. Questo tipo di scenario può valutare tutti i processi cognitivi e funziona particolarmente bene per valutare le capacità degli studenti di selezionare, usare le informazioni e valutarne la validità. La natura investigativa dei compiti dovrebbe essere sufficientemente stimolante e realistica.
- Studenti come mediatori o membri di un team. In questo scenario si chiede agli studenti che cosa suggerirebbero per moderare o risolvere i conflitti a scuola o nel vicinato. Il testo prende la forma di una conversazione dove due o più attori sono in conflitto su un problema. Le domande chiedono allo studente di identificare chi è coinvolto nella situazione, come sentono, pensano e reagiscono i differenti stakeholders e perché pensano e reagiscono in quel modo, basandosi sulla relazione fra i personaggi e le loro caratteristiche sociali e culturali. Allo studente si richiede di creare o identificare possibili soluzioni che considerino gli interessi di tutte o della maggior parte delle parti in causa. Questo tipo di scenario può effettivamente testare la capacità dello studente di riconoscere, articolare, posizionare e interpretare le molteplici prospettive degli stakeholders in un conflitto sociale dato e prevedere soluzioni che considerino ed integrino le differenti posizioni.
- Studenti come protagonisti di una discussione. I test richiedono di sviluppare argomentazioni e di paragonare differenti punti di vista su di un argomento in un dibattito. Lo scenario offre alcune informazioni di background sul problema che gli studenti possono usare per i loro interventi. Le domande chiedono di sviluppare o selezionare argomenti a favore della loro tesi e di contestare e contraddire gli argomenti della tesi opposta. Se trasposto in modo adeguato in un format valutativo, il dibattito può stimolare l’impegno dello studente e dare l’opportunità di dimostrare la propria capacità di pensiero e le proprie abilità comunicative.
Questa descrizione dei format di scenario non è esaustiva ed altri tipi di scenario possono essere esplorati durante il processo di sviluppo dei test.
Il format delle risposte
 La forma in cui le risposte sono raccolte varia a seconda del processo cognitivo che è valutato e del format scelto per lo scenario. Diversi tipi di risposta possono richiedere diverse abilità. Per esempio, test chiusi a scelta multipla dipendono di più dalle abilità di decodifica – se comparati ad item a risposte aperte – poiché i lettori debbono eliminare le risposte scorrette.
La forma in cui le risposte sono raccolte varia a seconda del processo cognitivo che è valutato e del format scelto per lo scenario. Diversi tipi di risposta possono richiedere diverse abilità. Per esempio, test chiusi a scelta multipla dipendono di più dalle abilità di decodifica – se comparati ad item a risposte aperte – poiché i lettori debbono eliminare le risposte scorrette.
Come in ogni valutazione su larga scala l’arco possibile dei format degli item è limitato ad alcune combinazioni di risposte aperte e chiuse. Tuttavia, gli item contestualizzati a risposta aperta sono particolarmente rilevanti per questa valutazione, poiché chiedono di assemblare componenti della conoscenza rilevanti, astratti, concettuali e specifici per un compito di problem solving. Gli item a risposta aperta sono stati già usati e validati nel Test Cognitivo Internazionale dell’ICCS, nei test sul civismo del NAEP e nell’esame GCSE del Regno Unito relativo all’educazione alla cittadinanza. Gli item a risposta aperta sono misurati usando rubriche/linee guida composte da dettagliate descrizioni qualitative degli standard di risultato. La maggioranza degli item dovrebbe includere almeno una domanda a risposta aperta.
Moderatori della performance: capacità di lettura, attitudini e valori.
 Certi fattori individuali che non sono esplicitamente valutati nel test cognitivo PISA 2018 possono tuttavia moderare la performance degli studenti.
Certi fattori individuali che non sono esplicitamente valutati nel test cognitivo PISA 2018 possono tuttavia moderare la performance degli studenti.
Capacità di lettura. Nella edizione 2018 dei test, gli scenari sono principalmente basati su test scritti, nonostante gli sforzi di integrare test ed immagini. Le capacità di cui gli studenti necessitano, per avere buoni risultati nei test di GC, si sovrappongono perciò in una certa misura con quelli richiesti per la Literacy di Lettura, poiché la definizione di PISA della Literacy di Lettura ha via via posto sempre più attenzione sulle capacità di analizzare, sintetizzare, integrare ed interpretare test multipli. Tuttavia questo Quadro di Riferimento identifica un insieme di capacità di comprensione prospettica e di ragionamento che chiaramente vanno al di là delle capacità di lettura e si focalizza sulla applicazione di queste abilità a specifici ambiti (temi globali ed interculturali). La loro specificità contribuisce a definire e determinare i processi cognitivi e le abilità impiegate nei compiti.
Sarà possibile misurare e parzialmente dar conto della correlazione fra competenze in lettura ed in GC poiché gli studenti testati saranno gli stessi e così i risultati dei singoli e dei Paesi nella GC potranno essere paragonati con quelli di lettura.
Le attitudini. Le attitudini possono facilitare la comprensione globale ed interculturale al livello affettivo e possono così agire come moderatori della performance nei test cognitivi. Alcuni esempi di attitudini che supportano le pratiche e lo sviluppo dei test cognitivi rispetto alle GC sono: la curiosità per le altre culture, la attitudine per la ricerca nei confronti di un arco ampio di temi globali, gli sforzi consapevoli di essere ben informati sugli eventi in corso a livello locale e globale, un positivo e rispettoso atteggiamento verso le differenze culturali ed il desiderio di fare qualcosa rispetto ai problemi globali che sfidano i bisogni e le libertà delle generazioni presenti e future (consapevolezza globale). Queste attitudini non saranno misurate direttamente nel test cognitivo. Tuttavia, nel questionario PISA di contesto, gli studenti diranno in che misura sono d’accordo con una serie di affermazioni relative a tali attitudini. La triangolazione dei risultati dei test cognitivi e delle informazioni su di sè offrirà una prova importante di come le attitudini supportano la comprensione globale ed interculturale.
I valori. Presumibilmente, il problema più complesso relativo alla messa in atto di questo quadro di riferimento valutativo è quello relativo ad una chiara definizione del modo in cui i valori influiscono sulla comprensione globale ed interculturale. Mentre i valori sono una parte integrante della GC, i test cognitivi di PISA non valutano i valori. I test proposti chiedono agli studenti di riflettere sulla validità e sulle conseguenze di alcune affermazioni e di elaborare le proprie conclusioni su uno specifico tema o situazione. Questo fatto richiede una attenta scelta delle prove che possono essere incluse nella valutazione internazionale cognitiva. Agli studenti si potrebbe chiedere di valutare affermazioni chiaramente giuste o sbagliate sulla base di criteri oggettivi, poiché aderiscono ad evidenze storiche o scientifiche o le contraddicono. Tuttavia, tutte le domande nel test cognitivo non dovrebbero mirare a valutare gli studenti in relazione alle loro opinioni o alla loro etica, ma piuttosto alla loro capacità di riconoscere e spiegare la complessità di un caso o la molteplicità delle possibili posizioni in proposito. Per esempio, in un ipotetico scenario che descrive il caso di un padre che ruba per nutrire i figli affamati, agli studenti non si dovrebbe chiedere se questa azione meriti o no una certa punizione, ma piuttosto di dimostrare di comprendere che in certe occasioni e per certi aspetti la legge può confliggere con fondamentali bisogni umani e di identificare o spiegare i possibili rischi e le conseguenti incertezze nel definire delle eccezioni a tali leggi.
INFORMAZIONI AUTODICHIARATE NEL QUESTIONARIO STUDENTE
 In aggiunta ai risultati della valutazione cognitiva, il rapporto sulla GC in PISA 2018 comprenderà informazioni a livello nazionale o di sottopopolazione sulle risposte di studenti, dirigenti scolastici, insegnanti e studenti alle domande del questionario.
In aggiunta ai risultati della valutazione cognitiva, il rapporto sulla GC in PISA 2018 comprenderà informazioni a livello nazionale o di sottopopolazione sulle risposte di studenti, dirigenti scolastici, insegnanti e studenti alle domande del questionario.
Trovare il giusto metodo di valutazione delle competenze socio-emozionali e delle attitudini, è probabilmente ancor più difficile che decidere cosa valutare. Non è praticamente possibile definire scale per attitudini e competenze autodichiarate che siano valide al 100%. La strategia adottata in PISA 2018 ha privilegiato l’uso e l’adattamento di scale che erano state già validate in altre valutazioni empiriche.
Il problema più comune in proposito è quello della accettazione o desiderabilità sociale. Le attitudini, in particolare, sono relazionate all’immagine di sé ed alla accettazione sociale. Per preservare un’immagine di sé positiva, gli studenti possono essere tentati di rispondere alle domande del questionario in un modo da loro ritenuto socialmente accettabile. Le scale di questo tipo di valutazioni che misurano le attitudini verso la razza, la religione, il sesso etc. sono particolarmente soggette a errori dovuti a prevenzioni sulla loro accettazione sociale.
Chi ha un atteggiamento negativo verso un particolare gruppo può non volerlo ammettere nemmeno con se stesso. In uno studio relativo ad atteggiamenti verso i rifugiati è stato trovato che l’accettazione/desiderabilità sociale influiva per l’8%.
C’è un gran numero di scale Likert nella letteratura relativa alle attitudini civiche e democratiche e una parte di esse riguarda la GC come definita in PISA. La scala di Global-Mindedness per esempio è stata sviluppata per “misurare le attitudini degli studenti relative al loro senso di responsabilità e interesse per la comunità globale e i comportamenti associati con questa prospettiva”. Le domande nella scala erano indirizzate sia alle opinioni che ai comportamenti: per esempio agli studenti si chiedeva in che misura concordavano con l’affermazione “tendo a giudicare i valori degli altri sulla base del mio sistema di valori”.
Facendo riferimento a questa letteratura, il Questionario Studente in PISA 2018 include domande che comprendono numerose affermazioni usando i metodi Likert. Queste domande sono basate il più possibile su lavori preesistenti, tenendo conto dei problemi del tempo a disposizione e della delicatezza della domanda e sono stati adattati al meglio alla realtà dei quindicenni. L’allegato C include le domande sulla GC che saranno incluse nel questionario di PISA 2018. Queste domande sono solo una parte di una gran quantità di materiali testati in tutti i Paesi partecipanti a PISA. Nel passaggio dal test alla somministrazione principale, alcune domande sono state tolte e alcune scale sono state accorciate per risparmiare tempo, assicurando tuttavia l’opportuna copertura di questo Quadro di Riferimento e mantenendo la validità psicometrica delle scale.
Sono disponibili su richiesta sia il questionario più ampio, testato nella prova sul campo di PISA, sia l’analisi della qualità psicometrica del materiale. L’analisi delle risposte a questi item supporterà i futuri sviluppi delle domande sulle attitudini e sulle competenze comportamentali ed emozionali che potrebbero essere inclusi nelle future edizioni di PISA. Il prossimo lavoro dopo il 2018 potrebbe anche prendere in considerazione l’integrazione di altri metodi per la misurazione di attitudini e “competenze sociali”, meno suscettibili di errori dovuti alla desiderabilità sociale delle risposte.
Conoscenze e capacità autodichiarate dagli studenti
 Conoscenze autodichiarate di temi globali e interculturali.
Conoscenze autodichiarate di temi globali e interculturali.
Un primo insieme di domande nel questionario studente copre la conoscenza di temi globali e interculturali. Una domanda nel questionario PISA 2018 chiede agli studenti di riferire con quanta facilità possono realizzare una serie di compiti relativi a problemi globali, come spiegare in che misura le emissioni di anidride carbonica influenzano il cambiamento climatico. Un’altra domanda richiede agli studenti di riferire del loro grado di famigliarità con alcuni temi globali come il cambiamento climatico e il riscaldamento globale, la salute.
Abilità autodichiarata di comunicare in un contesto multiculturale.
Un secondo insieme di domande si riferisce alle competenze linguistiche, di comunicazione e di comportamento richieste per comunicare con altre persone, per gestire gli intoppi nella comunicazione e per mediare fra differenti lingue e culture. La progressione dello studente in questo campo può essere valutata in relazione alle sue capacità nelle lingue straniere ed attraverso la loro abilità – sempre autodichiarata- di gestire la comunicazione con gente di altri retroterra culturali in un contesto non famigliare.
I dati autodichiarati sulle capacità nelle lingue straniere possono essere usati per esaminare la relazione fra l’acquisizione di una seconda lingua ed i livelli misurati di comprensione globale o di disposizioni positive verso gli altri e le altre culture. Una tale ricerca potrebbe avere alcune implicazioni politiche rilevanti, sia in relazione agli sforzi in atto per insegnare le lingue che in relazione ai programmi finalizzati ad incrementare il livello di comprensione degli studenti dei problemi globali.
Il questionario studente di PISA 2018 riferisce su quante lingue gli studenti ed i genitori conoscono ad un livello tale da poter conversare con gli altri. Esso include anche una domanda in cui si chiede agli studenti di valutare quanto sanno spiegare le cose, comprenderle o adattano il linguaggio quando parlano nel proprio linguaggio nativo con persone di linguaggio nativo differente.
Adattabilità audichiarata
La ricerca sulla comunicazione interculturale ha sviluppato e validato alcuni item e scale sulla adattabilità e la flessibilità. Per esempio la Intercultural Effectiveness Scale di Portalia e Chen del 2010 include misure autodichiarate di flessibilità comportamentale come il livello di accordo con l’affermazione “Io spesso agisco come una persona molto diversa quando interagisco con gente di culture differenti”. PISA 2018 include una domanda sulla adattabilità caratterizzata da molte (6) affermazioni prese da scale validate, che chiedono agli studenti come si comportano con le sfide connesse all’ interazione con persone di altri retroterra culturali.
Assunzione autodichiarata di prospettive.
Come nel caso della adattabilità ci sono alcune scale sulla assunzione di prospettive e sulla empatia che sono state specificamente definite per gli adolescenti e che sono state riviste per il questionario PISA. Nel questionario studente PISA una domanda composta da 5 item e che dovrebbe formare un costrutto unidimensionale valuta la capacità di assumere prospettive.
Attitudini autodichiarate dagli studenti
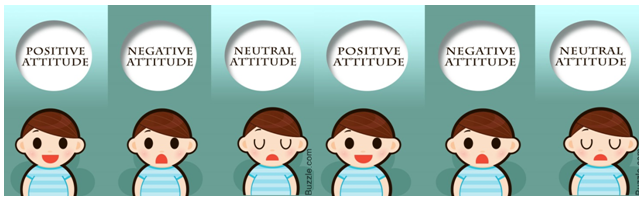
Apertura autodichiarata verso persone con altri retroterra culturali
Il questionario PISA include una domanda che valuta l’“interesse ad apprendere su altre culture” da parte degli studenti. La domanda valuta il desiderio o la volontà di imparare su altre religioni, culture e nazioni. La domanda include 4 item adattati da differenti fonti.
Rispetto autodichiarato verso persone con altri retroterra culturali.
Una domanda nel questionario PISA richiede agli studenti di riferire in che misura rispettano e valutano gli altri come esseri umani uguali a loro, indipendentemente dal loro retroterra culturale. La domanda è composta da 5 item adattati da differenti fonti.
Consapevolezza globale autodichiarata
Il questionario PISA comprende una domanda sulla consapevolezza globale. I 6 item compresi dovrebbero valutare i seguenti aspetti della consapevolezza globale: senso di cittadinanza globale, responsabilità per gli altri nel mondo, senso di interconnessione ed autoefficacia globale.
Domande del questionario su strategie, pedagogie ed attitudini per insegnare la GC

In PISA 2018 il questionario offrirà informazioni sulle innovazioni nei curriculi e sui metodi di insegnamento finalizzati a preparare gli studenti per la GC. Due domande si focalizzano sul curriculo. Una domanda chiede a dirigenti scolastici ed insegnanti se il curriculo include temi globali come cambio climatico e riscaldamento globale, salute globale o migrazione. Un’altra domanda richiede a dirigenti scolastici e insegnanti se il curriculo formale si riferisce anche alle abilità di GC ed a disposizioni come comunicare con persone di diversi retroterra culturali o nazioni oppure essere aperti ad esperienze interculturali.
Un secondo gruppo di domande si focalizza sulle opinioni e le pratiche degli educatori. Una domanda chiede ai dirigenti scolastici di riferire sulle opinioni generali dei loro insegnanti su come dovrebbero essere gestite le diversità etniche. Una seconda indaga su specifiche pratiche di apprendimento multiculturale a livello della scuola, come insegnare credenze, costumi o arti di diversi gruppi culturali che vivono nel Paese o incoraggiare gli studenti a comunicare con gente di altre culture attraverso Internet ed i socialmedia.
Due domande nel questionario PISA per gli insegnanti indagano sul loro livello di preparazione a rispondere ai bisogni di differenti comunità di studenti potenzialmente attraverso differenti strategie di insegnamento. Una domanda offre informazioni a proposito del fatto che un insegnante abbia studiato temi interculturali o ricevuto formazione in metodologie pedagogiche per insegnare in modo efficace in ambienti multiculturali. Un’altra domanda offrirà informazioni sulla capacità degli insegnanti di fare fronte alle sfide di una classe multiculturale e di adattare il loro insegnamento alla diversità culturale degli studenti. Il QS offre anche informazioni sul comportamento degli insegnanti dal punto di vista degli studenti. Una domanda in particolare chiede agli studenti di riferire se pensano che i loro insegnanti trattino gli studenti di tutti i gruppi culturali con uguale rispetto.
CONCLUSIONI
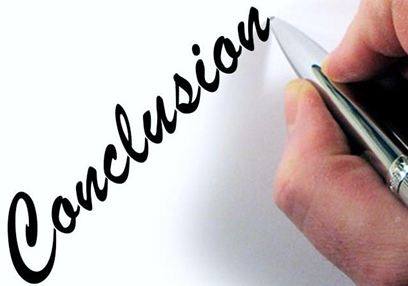 Come le scuole rispondono alla crescente interdipendenza economica, alle differenze culturali, alle nuove opportunità digitali ed agli appelli alla sostenibilità avrà un impatto significativo sul benessere di tutti i membri delle comunità. Tutti, sia nelle comunità omogenee che in quelle diversificate, sono chiamati a sfidare gli stereotipi culturali, a riflettere sulle cause della violenza razziale e religiosa ed a partecipare alla creazione di società rispettose, integrate e sostenibili.
Come le scuole rispondono alla crescente interdipendenza economica, alle differenze culturali, alle nuove opportunità digitali ed agli appelli alla sostenibilità avrà un impatto significativo sul benessere di tutti i membri delle comunità. Tutti, sia nelle comunità omogenee che in quelle diversificate, sono chiamati a sfidare gli stereotipi culturali, a riflettere sulle cause della violenza razziale e religiosa ed a partecipare alla creazione di società rispettose, integrate e sostenibili.
Raggiungere competenze globali attraverso l’educazione richiederà cambiamenti significativi nelle classi: cambiamenti concernenti ciò che gli studenti imparano sul mondo e sulle altre culture, le opportunità che hanno di praticare ciò che imparano e come gli insegnanti supportano questi apprendimenti lavorando con studenti di diverso tipo. Alcuni curriculi nazionali ora pongono attenzione alla educazione per uno sviluppo sostenibile ed alla educazione interculturale. Anche molti insegnanti incoraggiano gli studenti ad analizzare e riflettere sulle radici dei problemi globali ed a condividere idee sulle soluzioni possibili. Tuttavia il progresso è stato irregolare e le buone pratiche non sono state sufficientemente condivise a livello internazionale.
Il Quadro di Riferimento concettuale della GC e l’approccio che PISA assumerà per la prima valutazione internazionale del 2018 descritta nel documento offrirà il primo quadro complessivo del successo dei sistemi educativi nel preparare i giovani ad orientarsi verso lo sviluppo globale ed a collaborare produttivamente nella loro vita quotidiana pur attraverso le differenze culturali. I dati offriranno approfondimenti su quali approcci alla educazione globale siano più comunemente usati nei sistemi scolastici a livello mondiale e su come gli insegnanti siano preparati a promuovere la GC. I sistemi educativi impareranno in tale modo l’uno dall’altro come meglio adattare i curriculi, promuovere innovativi metodi di insegnamento ed adattare le formazione iniziale degli insegnanti e il loro aggiornamento in modo da facilitare lo sviluppo della GC.
I risultati possono anche stimolare l’innovazione a livello delle singole scuole, qualora le scuole cerchino un approccio efficace per migliorare la GC degli studenti. Un ampio arco di attività di apprendimento nelle classi può infatti influenzare la GC degli studenti e coinvolgere gli insegnanti di tutte le materie, anche se in misura diversa. Questo ampio arco può includere attività di gioco di ruolo che permettano agli studenti di assumere prospettive differenti, discussioni su pregiudizi e discriminazioni o attività basate su progetti che incoraggino gli studenti ad analizzare e riflettere sulle radici dei problemi globali.
Nessuna singola valutazione può pienamente dar conto della complessità della GC come obiettivo di apprendimento. L’approccio PISA riflette i bisogni ed i limiti di una valutazione internazionale su larga scala. Non è un sostituto della valutazione formativa della GC a livello di classe e di scuola. Al di là del 2018 altri sforzi saranno necessari per costruire sulle lezioni apprese da questa iniziativa e per migliorare ulteriormente la misurazione dei costrutti definiti nel Quadro di Riferimento. Il più sfidante, ma forse il più urgente tentativo sarà quello di sperimentare e valutare nuovi metodi per migliorare ulteriormente la misurazione delle dimensioni socio-emozionali e valoriali della Competenza Global.
Allegato A: domande relative alla GC nel QS
Quanto pensi ti riuscirebbe facile eseguire i seguenti compiti da solo?
(Barrare una sola casella per riga)
| Non sarei capace di farlo | Farei fatica a farlo da solo | Potrei farlo con un pò di sforzo | Potrei farlo facilmente | |
| Spiegare come le emissioni di diossido di carbonio influiscono sul cambiamento climatico. | ||||
| Stabilire un rapporto fra i prezzi dei tessuti e le condizioni di lavoro nei paesi di produzione. | ||||
| Discutere delle differenti ragioni per cui si diventa rifugiati. | ||||
| Spiegare perchè alcuni paesi sono più sottoposti di altri a cambiamenti climatici. | ||||
| Spiegare come le crisi economiche nei singoli paesi influenzano l’economia globale. | ||||
| Discutere le conseguenze dello sviluppo economico sull’ambiente. |
Quanto sei informato sui seguenti argomenti?
(Barrare una sola casella per riga)
| Non ne ho mai sentito parlare | Ne ho sentito parlare, ma non sarei capace di spiegare di cosa davvero si tratta | Ne so qualcosa e potrei spiegare l’argomento in generale | L’argomento mi è famigliare e sarei capace di spiegarlo bene | |
| Cambiamento climatico e riscaldamento globale | ||||
| Salute globale (vedi epidemie) | ||||
| Migrazioni (movimenti di persone) | ||||
| Conflitti internazionali | ||||
| Fame o malnutrizione in differenti parti del mondo | ||||
| Cause di povertà | ||||
| Parità fra uomini e donne in parti differenti del mondo |
Quanto ti descrive ciascuna delle seguenti affermazioni?
(Barrare una sola casella per riga)
| Molto | In gran parte | In qualche misura | Non molto | Per niente | |
| Cerco di guardare ad ogni lato di un argomento controverso prima di prendere una decisione. | |||||
| Io credo che ci siano due aspetti di ogni questione e cerco di guardare ad ambedue. | |||||
| A volte cerco di capire meglio i miei amici immaginando come sembrano le cose dalla loro prospettiva. | |||||
| Prima di criticare qualcuno, cerco di immaginare come mi sentirei se fossi al suo posto. | |||||
| Quando sono seccato con qualcuno, cerco di assumere la prospettiva di quella persona per un certo periodo. |
Quanto ti descrive ciascuna delle seguenti affermazioni?
(Barrare una sola casella per riga)
| Molto | In gran parte | In qualche misura | Non molto | Per niente | |
| Posso fronteggiare situazioni non usuali. | |||||
| Posso cambiare il mio comportamento per fronteggiare le necessità di situazioni nuove. | |||||
| Posso adattarmi a situazioni differenti anche quando sono sotto stress o sotto pressione. | |||||
| Posso adattarmi facilmente ad una nuova cultura. | |||||
| Quando mi trovo in situazioni difficili con gli altri, riesco a pensare ad un modo per risolvere la situazione. | |||||
| Sono capace di superare le mie difficoltà interagendo con gente di altre culture. |
Immagina di parlare nella tua lingua con gente la cui lingua native è differente dalla tua.
In che misura concordi con le seguenti affermazioni?
(Barrare una sola casella per riga)
| Sono in forte disaccordo | Sono in disaccordo | Sono d’accordo | Sono molto d’accordo | |
| Osservo attentamente le loro reazioni. | ||||
| Controllo spesso che ci stiamo capendo in modo corretto. | ||||
| Ascolto attentamente ciò che dicono. | ||||
| Scelgo attentamente le mie parole. | ||||
| Do esempi concreti per spiegare le mie idee. | ||||
| Spiego le cose molto attentamente. Se c’è un problema di comunicazione trovo il modo di affrontarlo (usando gesti, rispiegando, scrivendo etc). |
Sei coinvolto nelle attività seguenti?
(Barrare una sola casella per riga)
| Sì | No | |
| Riduco l’energia che uso a casa (diminuendo il riscaldamento, o manovrando l’area condizionata o spegnendo le luci quando si lascia una stanza) per proteggere l’ambiente. | ||
| Scelgo certi prodotti per ragioni etiche o relative all’ambiente, anche se sono un pò più cari. | ||
| Firmo petizioni online o sociali relative all’ambiente. | ||
| Mi tengo informato sugli avvenimentiI mondiali attraverso <Twitter> o <Facebook> | ||
| Boicotto prodotti o aziende per ragioni politiche, etiche o comportamentali. | ||
| Partecipo ad attività di promozione dell’eguaglianza fra uomini e donne. | ||
| Partecipo ad attività a favore della protezione ambientale. | ||
| Leggo regolarmente siti web su temi internazionali di tipo sociale (povertà, diritti umani). |
Quanto ti descrive ciascuna delle seguenti affermazioni?
(Barrare una sola casella per riga)
| Molto | In gran parte | In qualche misura | Non molto | Per niente | ||
| Voglio sapere come vive la gente nei diversi paesi. | ||||||
| Voglio saperne di più sulle religioni nel mondo. | ||||||
| Mi interessa come la gente di diverse culture vede il mondo. | ||||||
| Sono interessato a scoprire le tradizioni delle altre culture. | ||||||
Hai contatti con gente di altri paesi?
(Barrare una sola casella per riga)
| Sì | No | |
| Nella tua famiglia | ||
| A scuola | ||
| Nel tuo vicinato | ||
| Nel tuo circolo di amici |
Quanto ti descrive ciascuna delle seguenti affermazioni?
(Barrare una sola casella per riga)
| Molto | In gran parte | In qualche misura | Non molto | Per niente | |
| Rispetto la gente di altre culture come esseri umani alla pari. | |||||
| Tratto tutti con rispetto indipendentemente dal loro retroterra culturale. | |||||
| Do spazio alla gente di altre culture per esprimere se stessi. | |||||
| Rispetto i valori delle persone di diverse culture. | |||||
| Prendo in considerazione le opinioni delle persone provenienti da diverse culture. |
In che misura concordi con le seguenti affermazioni?
(Barrare una sola casella per riga)
| Sono in forte disaccordo | Non sono d’accordo | Sono d’accordo | Sono molto d’accordo | |
| Mi penso come cittadino del mondo. | ||||
| Quando vedo le condizioni di povertà in cui vivono delle persone nel mondo, sento la responsabilità di fare qualcosa. | ||||
| Penso che il mio comportamento possa avere ricadute su persone in altri paesi | ||||
| E’ giusto boicottare le aziende di cui si sa che offrono condizioni di lavoro negative a chi vi lavora. | ||||
| Posso fare qualcosa per i problemi del mondo. | ||||
| Aver cura dell’ambiente globale è importante per me. |
Le persone si stanno sempre più muovendo da un paese all’altro. Quanto concordate con le seguenti affermazioni sugli immigranti?
(Barrare una sola casella per riga)
| Sono in forte disaccordo | Non sono d’accordo | Sono d’accordo | Sono molto d’accordo | |
| Il bambini immigranti dovrebbere avere le stesse opportunità educative degli altri nel paese. | ||||
| Gli immigranti che vivono in un paese da alcuni anni dovrebbero avere l’opportunità di votare alle elezioni. | ||||
| Gli immigranti dovrebbero avere l’opportunità di mantenere le loro abitudini e stili di vita. | ||||
| Gli immigranti dovrebbero avere tutti gli stessi diritti degli altri nel paese. |
Quante lingue, inclusa/e la/e lingua/e che parli a casa, tu ed i tuoi genitori parlate abbastanza bene da conversare con altri?
(Barrare una sola casella per riga)
| Una | Due | Tre | Quattro o più | |
| Tu | ||||
| Tua madre | ||||
| Tuo padre |
Quante lingue straniere stai imparando nella tua scuola quest’anno?
(Per piacere, scrivi un numero. Scrivi 0 (zero) se quest’anno non segui a scuola nessun corso di lingua straniera)
Numero di lingue straniere: ____
Impari le seguenti cose a scuola?
(Barrare una sola casella per riga)
| Sì | No | |
| Imparo l’interconnessione fra le economie dei diversi paesi. | ||
| Imparo come risolvere I conflitti con gli altri in classe. Studio le differenti culture. | ||
| Leggo giornali, guardo le notizie su Internet o osservo le notizie insieme durante le lezioni. | ||
| Sono spesso invitato dai miei insegnanti a dare la mia personale opinione sulle notizie internazionali. | ||
| Partecipo ad eventi che festeggiano la diversità culturale durante l’anno scolastico. | ||
| Partecipo a discussioni in classe sugli avvenimenti mondiali come parte della normale istruzione | ||
| Analizzo I problemi globali con i miei compagni di classe in piccoli gruppi durante le lezioni. | ||
| Imparo che popoli di culture differenti possono avere prospettive differenti su alcuni temi. | ||
| Imparo come comunicare con la gente che proviene da differenti retroterra. |
Pensando agli insegnanti della tua scuola: a quanti di loro potrebbero adattarsi le seguenti affermazioni?
(Barrare una sola casella per riga)
| A nessuno o quasi | Ad alcuni | Alla maggioranza | A tutti o quasi tutti | |
| Hanno idee sbagliate sulla storia di alcuni gruppi culturali | ||||
| Dicono cose negative sulle persone di alcuni gruppi culturali. | ||||
| Biasimano le persone di alcuni gruppi culturali per problemi create dalla <nazione del test>. | ||||
| Hanno aspettative di apprendimento più basse per gli studenti di alcuni gruppi culturali |
Download
- PISA 2018 Quadro Riferimento Competenze Globali
- PISA 2018 Global Competence Framework
- PISA 2018 questionario GC



